|
Robert Fisk
Cronache mediorientali
il Saggiatore,
2006 |
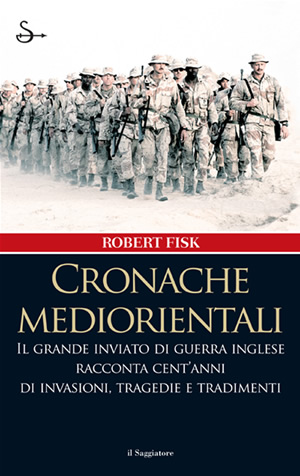
Bill Fisk, padre di Robert, ha fatto la Grande Guerra. Era il 1918 quando, tornati dal fronte, i vincitori, pochi uomini, divisero terre, fecero promesse, rispettarono e tradirono alleanze. Nell’arco di soli 17 mesi si stabilirono i confini dell’Irlanda del Nord, della Jugoslavia e di quasi tutto il Medio Oriente, disegnato come lo conosciamo oggi.
In quel momento nasce anche Cronache Mediorientali.
Cent’anni di invasioni, tragedie e tradimenti, di torture, esecuzioni e genocidi, di dolore, ingiustizia e orrore. Ventuno capitoli per ventuno storie - le prime quattro proposte in anteprima con Diario la prossima settimana per gentile concessione della casa editrice il Saggiatore che esce il 9 novembre in libreria con l’edizione integrale - storie diverse e uguali che parlano di uomini e donne, di vite, di eroismo e tradimento. Cambiano i protagonisti, i vincitori e i vinti, gli amici e i nemici, i buoni e cattivi, ma una cosa non è cambiata nella cronaca del Medio Oriente: il bisogno di chiedersi ancora «Perché?».
Da Belfast a Sarajevo, da Beirut a Baghdad, Robert Fisk ha passato gran parte della vita in mezzo ai conflitti più caldi, a vedere e a raccontare di gente saltata per aria dentro i confini stabiliti dalla guerra del padre. Come se la Storia fosse «una gigantesca cassa di risonanza» e la guerra «una questione tra morire o infliggere la morte». Ricorda i soldati iraniani che, sul treno che li trasportava a nord verso Teheran, «espettoravano negli asciugamani il gas di Saddam in grumi di sangue e muco leggendo il Corano». Rende indimenticabile quel padre iracheno che nel 2003, dopo un attacco americano con le bombe a grappolo, gli tese con le mani «quella che sembrava una forma di pane spiaccicata ma in realtà era un neonato». Non soffre di incubi per questo. Ma non dimentica. Non risponde a una volontà di scioccare, ma di spiegare, «affinché nessuno possa dire: “Non sapevamo – nessuno ce lo aveva detto”».
Un tempo sosteneva che ogni reporter dovrebbe portare con sé, nella tasca posteriore dei pantaloni un libro di storia. «Tutti noi dovremmo essere cronisti», ama ripetere.
In appendice al libro la miglior bibliografia sull'argomento
Robert Fisk è nato a Maidstone, nel Kent, nel 1946. Attualmente è corrispondente da Beirut per il quotidiano inglese The Independent. Secondo il New York Times è l’inviato di guerra più famoso al mondo, e di certo è quello che ha vinto il maggior numero di riconoscimenti per il suo lavoro. Ha cominciato la sua carriera nei primi anni settanta a Belfast e in Portogallo come inviato del Times, per poi trasferirsi definitivamente in Medio Oriente nel 1976. Fisk è l’unico giornalista occidentale ad avere intervistato bin Laden – tre volte, tra il 1994 e il 1997 – ed è uno dei pochi a parlare arabo perfettamente. In Italia i suoi articoli sono apparsi su la Repubblica, l’Unità e Internazionale<, e i suoi libri sono bestseller in tutti i continenti.
Justin Podur intervista Robert Fisk

Robert Fisk è uno dei giornalisti più conosciuti del mondo. Come corrispondente dell'Independent, ha vissuto per quasi trent’anni in Medio Oriente, nel corso dei quali è stato cronista delle due guerre statunitensi contro l’Iraq, di due guerre in Afghanistan, del cnflitto israeliano-palestinese, dell’invasione del Libano da parte di Israele, della guerra civile nell’ex Jugoslavia.
Il suo nuovo libro Cronache mediorientali (uscito per HarperCollins nel 2005, il Saggiatore nel 2006) raccoglie i suoi reportage in un unico volume di 1150 pagine. Un libro precedente di 700 pagine, Pity the Nation (quarta edizione Nation Books, 2002), trattava la guerra civile in Libano.
Fisk è apprezzato ovunque per essere un instancabile reporter che fa di tutto per ottenere informazioni di prima mano e conferire imparzialità, competenza e conoscenza della storia ai propri articoli. Il suo lavoro si fonda su un presupposto morale, che vede la guerra come la «totale sconfitta dello spirito umano» e i giornalisti come responsabili di raccontare i fatti dal punto di vista delle vittime. Il 24 novembre l’ho incontrato a Toronto per discutere del suo libro, della sua idea di giornalismo e della guerra.
Podur: A che cosa attribuisce l’ampio numero dei suoi lettori?
Fisk: Fatta eccezione per il New York Times, il Los Angeles Times e il Washington Post, la versione dei fatti della stampa tradizionale – per la verità odio quest’espressione – lascia insoddisfatti milioni di persone. Sempre più gente cerca di trovare una versione degli eventi in Medio Oriente differente e più accurata. Ed è un tributo che fanno alla loro intelligenza rivolgersi ai quotidiani «tradizionali» europei come l’Independent, il Guardian e il Financial Times, invece di consultare un blog o cose di questo genere.
Una delle ragioni per cui leggono l’Independent è che vi ritrovano quello che sospettavano essere la realtà dei fatti, ma pubblicate da un giornale importante. Non pubblico i miei articoli su un sito internet. L’Independent è una grande operazione che prevede corrispondenti esteri. Siamo l’equivalente britannico di quello che dovrebbe essere il Washington Post.
Oltre metà della posta che ricevo proviene dagli Stati Uniti. Ciò non significa che non abbiamo lettori in Gran Bretagna, significa che ne abbiamo tantissimi in America. Questo vale anche per il Guardian. In Pakistan, India, Bangladesh, Sudafrica, Stati Uniti, Canada e molti altri paesi, la gente sta scoprendo che un giornalista britannico ha la libertà di scrivere cose che non si possono leggere altrove, ma che devono essere attendibili perché altrimenti non apparirebbero su uno dei principali quotidiani britannici.
Non sono un eccentrico di sinistra o un pazzoide di destra. Siamo un quotidiano, questo è il punto. Questo ci conferisce autorevolezza: molta gente è cresciuta con i giornali. Internet è una cosa nuova, e oltretutto è inaffidabile.
Podur: Può spiegare perché odia la definizione «media tradizionali»?
Fisk: Quest’espressione è diventata un cliché. Anche nelle università, soprattutto negli Stati Uniti, troviamo un sacco di persone che si definiscono «attivisti». Non mi è chiaro che cosa intendano: siamo tutti «attivisti» se ci alziamo la mattina. Siamo «attivisti» quando beviamo un caffè. Mentre gli «attivisti» trascorrono ore mandandosi email senza altro scopo che dirsi «stiamo perdendo».
E continuano a dire «tradizionale» e «alternativo». Il problema è che se io sono una persona comune che non appartiene all’élite universitaria e devo scegliere tra un quotidiano «tradizionale» e uno «alternativo», sceglierò quello «tradizionale» perché è più rassicurante, giusto? Perché non chiamate i vostri giornali «tradizionali», e il New York Times «alternativo»?
Podur: Nel suo libro parla anche di giornalismo. Che cosa pensa di valori come obiettività, onestà, equilibrio e neutralità nel giornalismo?
Fisk: Se guardiamo tutti i giorni i quotidiani statunitensi, vedremo che la copertura delle notizie dal Medio Oriente è deplorevole e incomprensibile. Si adottano stratagemmi semantici per evitare polemiche, soprattutto da parte dei sostenitori di Israele. Le colonie diventano «quartieri», occupato diventa «conteso» e un muro si trasforma magicamente in uno «steccato»… voglio dire, spero che casa mia non sia fatta di «steccati»!
Per anni il giornalismo è stato rinchiuso, plagiato, imprigionato in una camicia di forza di regole create negli anni quaranta proprio nelle scuole di giornalismo degli Stati Uniti. Queste scuole sono state introdotte per formare i giornalisti dei quotidiani locali. Se per esempio devi affrontare una disputa che riguarda la costruzione di un’autostrada, o la proprietà pubblica o privata di un aeroporto, è essenziale offrire a quelli che si oppongono lo stesso spazio dato a quelli che vogliono aprire un nuovo aeroporto. In un tribunale, è fondamentale che accusa e difesa abbiano lo stesso tempo a disposizione.
Se parliamo di giornalismo locale di questo tipo – un’inchiesta pubblica, un caso legale, una battaglia per un ospedale nuovo – entrambe le parti hanno diritto di esprimersi perché non si tratta di una questione morale. Diventa una questione morale nella misura in cui la comunità ha bisogno di un buon ospedale e i proprietari di case hanno diritto alla privacy senza doversi preoccupare dei progetti del governo, ma non stiamo parlando di un grande, scottante argomento morale come la vita, l’uccidere o la guerra.
Nel primo caso è corretto assicurarsi che siano tutti equamente rappresentati. Ma nel campo della politica estera, in una parte del mondo in balia dell’ingiustizia, dove ogni anno migliaia di persone vengono dilaniate dalle armi, entriamo in una diversa prospettiva, dove gli standard della neutralità adottati nel tribunale di una piccola città vengono a cadere perché non hanno più alcun senso.
Quando vedi i corpi dei bambini accatastati sul luogo di un massacro non è il caso di dare pari spazio agli assassini. Se fossimo nell’Ottocento e stessimo facendo un articolo sulla tratta degli schiavi, non daremmo il cinquanta per cento di spazio al capitano della nave; ci occuperemmo degli schiavi che sono morti e dei sopravvissuti. Se fossimo presenti alla liberazione di un campo di sterminio nella Germania nazista, non offriremmo il cinquanta percento dello spazio alle ss perché commentino l’episodio.
Quando in Israele, a Gerusalemme Ovest, nel 2001 mi trovai nei pressi di una pizzeria in cui morirono venti persone (più della metà bambini) per l’esplosione di una bomba, non concessi metà dello spazio ad Hamas. Nel 1982, a Sabra e Shatila, scrissi delle vittime, dei morti che dovetti scavalcare fisicamente e dei sopravvissuti. Non dedicai il cinquanta percento alla milizia falangista libanese cristiana che li massacrò, e neppure all’esercito israeliano che rimase a guardare gli assassini senza fare nulla.
Nell’ambito della guerra, che rappresenta la sconfitta totale dello spirito umano, come giornalisti siamo moralmente obbligati a esprimere in modo esplicito compassione per le vittime e a non avere paura di fare i nomi degli assassini. Ci è concesso di essere pieno di rabbia. La cameriera che ci serve il caffè, il tassista che mi ha portato qui non sono indifferenti alle atrocità. Perché dovremmo esserlo noi?
Podur: Se la guerra è la sconfitta totale dello spirito umano, se non riguarda vittoria e sconfitta ma sofferenza e morte, perché sono in tanti a farla?
Fisk: Perché non sanno cos’è. Molti dei soldati in Iraq non erano mai stati in guerra prima. La loro personalità è stata totalmente trasformata da questa esperienza. Non erano assolutamente preparati: conoscono soltanto Hollywood. Salvate il soldato Ryan si avvicina molto a quello che vedo, ma è appunto solo nell’ambito della finzione che puoi vedere certe cose, non le vedrai mai alla tv, non te le faranno mai vedere, perché farlo sarebbe autentico, pornografico, osceno. Non puoi guardare certa roba mentre fai colazione, giusto?
Io queste cose le vedo a colazione, a pranzo e anche all’ora del tè; voi no, voi siete protetti da quelle brave persone di Londra, New York e Washington, dai produttori: non vogliono disonorare i morti. È come se fosse giusto uccidere gli iracheni, ma non mostrarli dopo: solo a quel punto siamo preoccupatissimi per il loro onore. Li compatiamo talmente quando sono morti che non possiamo farli vedere in fotografia. Ma finché sono vivi, diamoci dentro! «guerra in iraq, quinto episodio»… allora si può girare un film di guerra e farci un sacco di soldi; ma è solo dopo averle uccise che alle persone si riconoscono compassione e onore.
Certo, esistono anche politici conniventi che vogliono presentare la guerra come un recinto di sabbia privo di sangue dove anche se la gente muore… Si può mostrare la foto di un iracheno morto solo se è stato tanto cortese da morire in un punto che si staglia contro l’orizzonte: «Il prezzo della guerra: il corpo di un soldato iracheno giace nel deserto a sud di Basra». Ma non lo vedrai mai con gli occhi fuori dalle orbite o ricoperto di mosche.
Non esiste un solo membro dell’attuale amministrazione Bush che sia mai andato in guerra. Colin Powell è stato in Vietnam, ma al massimo nell’amministrazione. Lo stesso vale per il governo Blair. Qualche parlamentare laburista è andato in Irlanda del Nord da militare, ma si tratta di una cosa diversa. I politici che governano i nostri paesi non hanno alcuna esperienza della guerra.
Podur: Se si crede, come lei, che la guerra sia la sconfitta totale dello spirito umano, non diventa ancora più difficile spiegarne i motivi, cosa che secondo lei i reporter dovrebbero fare?
Fisk: Esiste forse una guerra giusta? Quando l’arcivescovo di Canterbury dichiarò che la liberazione americana del Kuwait era una guerra giusta (cosa che non ha detto della Bosnia, forse perché lì non c’era il petrolio, chissà...) ero disgustato. Dobbiamo per forza avere ancora religiosi che ci parlano di guerre giuste? È ora di finirla.
La guerra è un atto immorale. Prendo una citazione da Guerra e pace di Tolstoj dal quindicesimo capitolo del mio libro. «... scoppiò la guerra: un evento contrario alla ragione e alla natura umana divenne realtà. Milioni di uomini commisero, gli uni al danno degli altri, un numero indicibile di misfatti, tradimenti, ladrocinii, rapine, incendi e assassinii, falsi in assegni e denaro, quali per secoli non ne annoverano le cronache di tutti i tribunali del mondo. E invece durante quel periodo gli uomini che se ne macchiarono non li considerarono nemmeno reati.» Non c’è nient’altro da aggiungere.
Podur: Che cosa spera di ottenere con il suo libro?
Fisk: Quando lo stavo scrivendo non conoscevo la risposta, ma adesso sì. Voglio che i lettori rifiutino la versione della storia scritta da presidenti, primi ministri, generali e giornalisti. Lanciare una sfida alla versione «ufficiale» della storia, o monitorare i centri di potere, per usare una frase di Amira Hass, significa che dobbiamo avere una nostra visione del mondo ripulita dai cliché e da parole vuote come «guerra al terrore», «terrorista», «terrorismo islamico», «attacco chirurgico», «bene e male», «noi e loro», «odiano la nostra libertà», «democrazia»… una «democrazia» portata con la forza militare, con i carri armati Abrams e gli elicotteri Apache.
Continuiamo a minacciare il Medio Oriente con la democrazia. Ma gli arabi musulmani preferirebbero delle democrazie, diritti umani e libertà che non abbiano niente a che vedere con gli scaffali dei nostri supermercati occidentali. È un altro il genere di libertà che vorrebbero, ed è la libertà da noi. Vorrebbero anche giustizia, ma questo nessuno lo dice mai.
Il libro racconta la storia del Medio Oriente come nessuno ha mai fatto prima, dal punto di vista di un testimone oculare che vi ha vissuto a lungo. Non tralascia niente, comprese lunghe sezioni storiche ed epiche, e si conclude con l’occupazione dell’Iraq. Per un secolo noi occidentali abbiamo controllato il Medio Oriente, nominato dittatori, e non si potrà mai capire l’11 settembre a meno di vedere quello che abbiamo fatto in quella regione del mondo.
|