 |
Lilian Hellman
Un amico, un certo Hammett |
Scherzammo per anni a proposito della mia intenzione di scrivere di lui. Agli inizi, dicevo: "Parlami di quella ragazza di San Francisco. Di quella scema che abitava sullo stesso pianerottolo in Fine Street..." E lui rideva e diceva: "Viveva sullo stesso pianerottolo in Fine Street ed era scema". "Dimmi qualcosa di più. Se ti piaceva molto e se..." Lui sbadigliava. "Finisci di bere e vai a dormire." Ma poi, qualche giorno dopo, se non la sera stessa, quando ero in vena d'investigazioni (lo fui quasi sempre durante tutti quegli anni) insistevo: "Va bene, ti ostini a non parlare delle ragazze, parlami allora di tua nonna e di com'eri da bambino..." "Ero molto grasso. Mia nonna andava al cinema ogni pomeriggio, le piaceva molto un attore che si chiamava Wallace Reid e tutto questo te l'ho già raccontato." Allora dicevo che volevo avere tutto pronto per quando, dopo la sua morte, avrei scritto la sua biografia; e lui replicava che non mi dessi la pena di scrivere la sua biografia, perché ne sarebbe venuta fuori la storia di Lillian Hellman, con qualche saltuario riferimento a un amico, un certo Hammett.
Dal giorno della sua morte, il 10 gennaio 1961, sono passati ormai quasi cinque anni, ma non scriverò mai quella biografia, perché non me la sento di scrivere dell'amico più intimo e adorato e, forse, anche perché durante i trentun anni di vita separata e comune tutte quelle domande e le occasionali risposte finirono col confondersi, la vita cambiò per lui e per me e domande e risposte sono diventate in ultimo una cosa sola, che abbraccia i giorni in cui ero giovane e quelli in cui non lo ero più.
E, dunque, questo non vuole essere il tentativo di una biografia di Samuel Dashiell Hammett, nato nella contea di St. Mary, nel Maryland, il 27 maggio 1894; né vuole essere una valutazione critica dei racconti inclusi in questo volume.
Ci fu un tempo in cui li giudicavo tutti ottimi. Invece non tutti lo sono; quasi tutti, forse, ma non tutti. Ed è doveroso dire subito che, pubblicandoli, faccio quanto Hammett non aveva mai voluto fare: infatti, rifiutò ogni offerta di ripubblicare questi racconti, e non ne ho mai saputo il motivo né mai l'ho chiesto. Sapevo però - da quanto lui mi diceva a proposito di Tulip, il romanzo incompleto che è incluso in questo volume - che, come scrittore, aveva intenzione d'iniziare una nuova vita. Forse non voleva che i vecchi scritti costituissero per lui un ostacolo. A volte, invece, penso che fosse troppo malato per pensarci, troppo stanco per stare ad ascoltare proposte e leggere contratti: il solo e unico fatto di respirare, di vivere ancora, gli assorbiva tutti i giorni e tutte le notti.
Una polmonite contratta al fronte durante la prima guerra mondiale si tramutò in tubercolosi; di conseguenza dovette trascorrere vari anni in sanatori militari. Dalla seconda guerra mondiale tornò con un enfisema polmonare; ma come fosse riuscito, all'età di quarantott'anni, a partecipare alla seconda guerra mondiale è per me ancora fonte di meraviglia. Il giorno in cui l'esercito lo accettò e arruolò, mi telefonò per dirmi che quello era il giorno più felice della sua vita, e prima ancora che fossi riuscita a spiegargli che non lo era invece della mia e a chiedergli come la metteva con le vecchie cicatrici ai polmoni, scoppiò a ridere e riattaccò. La morte fu causata da cancro ai polmoni, scoperto soltanto due mesi prima della fine. Non era operabile - e dubito che avrebbe consentito a farsi operare, qualora lo fosse stato - e così decisi di non dirgli niente del cancro. Il medico spiegò che il dolore lo avrebbe preso alla parte destra del petto e al braccio destro, ma che sarebbe potuto anche non venire. Quel medico si sbagliava: lo aveva appena detto, e il dolore venne, a distanza di poche ore. Hammett, per conto suo, si era diagnosticato un reumatismo al braccio destro, e aveva sempre detto che per questo motivo aveva smesso d'andare a caccia. Lo stesso giorno in cui io appresi del cancro, mi disse che la spalla destra, dove portava la carabina, gli dava di nuovo fastidio, e mi chiese di grattargliela. Ricordo che mi misi dietro a lui e che gliela grattai, sperando che lui rimanesse sempre convinto che si trattava di un reumatismo; e ricordo, ancora, solo i giorni di caccia, in autunno. Il dolore, d'altro canto, non si ripresentò più, o, se si ripresentò, lui non disse niente o, forse, la morte era così vicina che il dolore alla spalla si confuse con gli altri.
 Non voleva morire, e a me piace pensare che allora ignorasse che stava invece morendo. Non voleva morire, e a me piace pensare che allora ignorasse che stava invece morendo.
Ma, ancora oggi, evito di pensare al senso di quanto disse una sera, negli ultimissimi tempi, poco prima di morire. Entrai nella sua stanza e, per la prima volta in tanti anni che lo conoscevo, vidi bagnati i suoi occhi e intatto il libro che stava leggendo. Andai a sedermi accanto al letto e attesi un bel po' prima di riuscire a dire: "Vuoi parlarne?..." Quasi con stizza, rispose: "No, il mio unico scampo è di non parlarne". E non se ne parlò mai.
La sua pazienza, il suo coraggio, la sua dignità, in quei lunghi mesi di pena, furono grandissimi. Fu come se tutte le virtù d'un uomo si palesassero insieme, contemporaneamente: la sofferenza era una faccenda privata, e al riguardo non dovevano esserci intrusioni. Non chiedeva nemmeno quello di cui aveva bisogno e così noi - io e la mia segretaria e la cuoca, che gli erano devote come sempre gli erano state devote quasi tutte le donne - ci limitavamo a portargli su in camera i pasti, che egli quasi non toccava, i libri che ora a stento riusciva ad aprire, il caffè pomeridiano e il martini che io insistevo per fargli bere prima del pranzo che non toccava. Una sera dell'ultimo anno, una brutta sera, gli dissi: "Prendi un altro martini, ti farà bene..." "No" rispose lui "non lo voglio." Io dissi: "Okay, ma non avrei mai immaginato di dover insistere per farti bere..." Per la prima volta quel giorno, rise. "Già, e io non avrei mai immaginato di dover rifiutare."
La prima sera che lo conobbi, infatti, stava riprendendosi da una sbornia di cinque giorni, e nei diciott'anni che seguirono non fece altro che bere. Poi, un giorno, messo in guardia da un medico, promise di non toccare mai più l'alcool; e mantenne la parola, tranne nell'ultimo anno, per quel martini al giorno - che fu una mia idea.
Ci conoscemmo a Hollywood, in un ristorante, quando io avevo ventiquattro anni e lui trentasei. Dopo cinque giorni di sbornia, il suo volto bellissimo era sciupato, e la figura alta e sottile era stanca e curva. Parlammo di T. S. Eliot, ma non ricordo più quello che dicemmo; poi uscimmo e rimanemmo seduti nella sua macchina a parlare e parlare, sino all'alba. Ci incontrammo di nuovo dopo parecchie settimane e, da allora in poi, ancora e sempre, per tutto il resto della sua vita e per trenta anni della mia.
Trent'anni sono molti, forse, e tuttavia, ora che mi accingo a scrivere di quel tempo, i ricordi mi sfuggono, si confondono, e mi rendo conto che solo di pochi tra tanti posso fidarmi. Ricordo quel primo incontro e il successivo e molte immagini e parole, ma senza nessun ordine, né logico né cronologico; né provo desiderio di dar loro una sistemazione - avrei potuto fare un lavoro di ricerca, l'ho già fatto per altri, ma per Hammett non me la sono sentita, non ho voluto tenere la contabilità della mia vita. Non che voglia mostrarmi riservata circa quanto riguarda noi due, ma mi chiedo adesso, in questo momento, se possa avere alcun senso per altri che per me il fatto che il secondo e più vivo ricordo sia quello d'un giorno al tempo in cui vivevamo su un'isoletta, al largo della costa del Connecticut. Erano passati sei anni da quando ci eravamo conosciuti: sei anni di felicità e infelicità, durante i quali, con l'aiuto di Hammett, avevo scritto la mia prima commedia. Tornavo all'isola dalla terraferma con un catboat carico dei pacchi della spesa, e Hammett era sceso giù al molo ad aiutarmi nell'attracco. Era stato male quell'estate - il primo dei mali - ed era anche più magro del solito. Nell'ultimo sole, i capelli bianchi e i pantaloni e la camicia bianchi formavano come una superficie piatta e dritta. Mi parve allora che quella fosse l'immagine più bella mai capitatami sotto gli occhi - quell'uomo affilato, quel naso sottile - e la scotta mi sfuggì di mano e il vento sfuggì dalla vela. Vedendomi alle prese con scotta e vela, Hammett rise e io, non so perché, gridai arrabbiata: "Eccoti lì, come il santo-peccatore di Dostojevskij. Tu questo sei...!" Smise di ridere, e, quando finalmente sbarcai e ci caricammo dei pacchi, non parlammo; e non parlammo durante tutto il pranzo. Più tardi, la sera, chiese: "Perché l'hai detto? Cosa significa?" Risposi che non sapevo perché l'avessi detto né cosa significasse.
Anni dopo, quando la sua vita cambiò, capii cosa avessi voluto dire quel giorno: avevo visto il peccatore - per quel che è un peccatore - e avevo sentito il cambiamento prima che avvenisse. Quando glielo dissi, Hammett replicò che non capiva di cosa parlassi, c'era dentro troppa religione perché lui capisse. Invece capì benissimo di cosa parlavo, e ne fu anche compiaciuto.
Ma ormai, quando facevamo quei discorsi, gli anni grassi, irrequieti, sfrenati, erano finiti. Quando conobbi Dash, aveva scritto già quattro dei suoi cinque romanzi ed era il "tipo sulla breccia" a Hollywood e a New York. Non è eccezionale essere sulla breccia in quelle due città - sulla breccia ci si alterna a ogni stagione invernale - ma nel suo caso si aggiungeva anche l'interesse del fatto che l'ex detective, che dalle sue zuffe coi criminali era uscito con brutte cicatrici sulle gambe e un taglio alla testa, era un uomo di buone maniere, ben educato, di figura elegante, eccentrico, brillante e, in più, spendeva tanto denaro con le donne che sarebbe stato amato anche se non fosse stato affatto sulla breccia. Poi, in tutti gli anni dal 1930 al 1948, scrisse invece un solo romanzo e pochi racconti.
Nel 1945, il bere già non era più un fatto allegro per lui, le sedute dedicate all'alcool erano più lunghe e l'umore era più tetro. Io ero lì durante quegli anni, con lui e lontana da lui; ma nel 1948 non volli più assistere a tanta dissipazione. Non lo vidi e non gli parlai per due mesi, finché un giorno la sua devota domestica a ore non mi chiamò per dirmi che avrei fatto bene ad andare da lui. Dissi che non ci sarei andata; ma poi andai. Lei e io aiutammo a vestirsi un uomo incapace di sollevare un braccio o una gamba e lo portammo a casa mia. E quella notte vidi e conobbi il delirium tremens, anche se non me ne resi conto finché non me lo disse il medico, il giorno dopo all'ospedale. Era un vecchio amico, quel medico; disse anche: "Non posso non dirlo a Hammett, se continua a bere in pochi mesi sarà morto. Ho il dovere di dirglielo, ma non servirà a niente". Pochi minuti dopo, uscì dalla stanza di Dash e disse: "Gliel'ho detto. Ha risposto che sì, va bene, lui smetterebbe, ma non può e non vuole". Invece potè e smise davvero. Cinque o sei anni dopo, quando raccontai a Hammett che il medico aveva detto che lui non voleva smettere di bere mi guardò perplesso: "Ma gli diedi la mia parola, quel giorno!" Gli chiesi: "E hai mantenuto sempre la tua parola?" "Quasi sempre" rispose "forse perché l'ho data di rado."
Aveva "scelto" l'onore quand'era ancora giovanissimo, e si era aggrappato ai suoi princìpi, fiero e ostinato nell'attenervisi. Nel 1951 andò in prigione perché, insieme con altri due amministratori del fondo-cauzioni del Civil Rights Congress, s'era rifiutato di rivelare i nomi dei sottoscrittori. La verità era che Hammett non aveva mai messo piede nell'ufficio del comitato e non conosceva il nome di neppure uno dei sottoscrittori. La sera prima del processo gli chiesi: "Perché non dici che non li conosci i nomi...?" "No" rispose "non posso dirlo." "Perché?..." "Non lo so perché." Tacemmo, nervosi entrambi, poi lui aggiunse: "Perché intendo mantenere la mia parola, credo che sia questo il motivo. Ma non voglio parlarne. Non accadrà niente, o quasi, anche se temo che dovrò andare in galera per un po'... ma tu non devi preoccuparti perché..." e a questo punto, improvvisamente, non riuscii più a capirlo perché aveva abbassato la voce in fretta e, cosa insolita in lui, in maniera nervosa. Gli dissi che non sentivo, lui alzò la voce e abbassò il capo: "Odio queste maledette chiacchiere, ma in ogni caso voglio dirti che, se si trattasse di qualcosa di più che la galera, se si trattasse della mia vita, la darei per quella che ritengo sia la democrazia. E non tollero che giudici e poliziotti vengano a dirmi loro che cosa è la democrazia". Dopodiché se ne andò a casa a letto, e il giorno dopo in galera.
14 luglio 1965
È un bellissimo giorno d'estate. Quattordici anni fa, in un altro bellissimo giorno d'estate, l'avvocato al quale Hammett aveva detto di non volere né aver bisogno di parlare, e col quale alla fine aveva acconsentito a parlare esclusivamente perché questo mi avrebbe fatto star meglio, tornò dalla prigione di West Street con un messaggio di Hammett; se l'era scritto sul retro di una busta: "Dica a Lily di andar via. Le dica che non m'occorrono prove del suo amore, né le voglio". Così me ne andai in Europa, e da lì scrissi una lettera quasi ogni giorno, ignorando che gliene veniva consegnata più o meno una su dieci, e senza mai ricevere risposta da lui, perché non gli era permesso scrivere a chi non era suo parente - intanto, era stato trasferito in un penitenziario nella Virginia Occidentale. Ebbi solo un messaggio quell'estate: in prigione, il suo lavoro era pulire i gabinetti, e li puliva meglio di quanto li avessi mai puliti io!
Tornai a New York per incontrare Hammett la sera in cui uscì. La galera aveva reso più magro un uomo magro, più malato un uomo malato. Provato nel fisico, tentò di camminare dritto e a testa alta, ma nello scendere la scaletta dell'aereo dovette reggersi al passamano e, prima di scorgermi, incespicò e dovette fermarsi a riposare. Fu allora, credo, che capii per la prima volta che sarebbe restato malato per sempre. Mi sentii troppo a disagio per salutarlo, rientrai di corsa nell'edificio dell'aeroporto e ci ritrovammo solo dopo un po'. In capo a una settimana, tuttavia, quando ebbe dormito abbastanza e fu in grado di mangiare piccole quantità di cibo, ebbe inizio una storia irritante, che sarebbe durata per tutto il resto della sua vita: dopotutto, in galera non si sta male. Proprio così; il cibo è disgustoso e spesso anche rancido, ma puoi sempre chiedere latte; i contrabbandieri d'alcool e i ladri d'auto sono imbecilli, ma la loro conversazione non è più stupida di quella che si sente a un qualsiasi cocktail party a New York; pulire gabinetti non piace a nessuno, ma col tempo finisci anche con l'andar fiero del tuo lavoro e con l'interessarti agli attrezzi e al materiale per la pulizia; i carcerati omosessuali sono disgustosi, ma non più di quelli che puoi incontrare in un qualsiasi bar, e così via. Per questa sua forma di civetteria, come per il suo senso del comico, Hammett tendeva sempre a ridersela dei guai e dei dolori. Una volta incontrammo per strada Howard Fast, che ci disse della condanna che avrebbe dovuto scontare; quando ci incamminammo, Hammett disse: "Ti risulterà tutto più semplice, Howard, se per prima cosa ti togli di testa questa corona del martire". E fu forse allora che capii che Hammett parlava della sua esperienza in prigione come molti di noi parlano della loro esperienza nel college.
Non desidero evitare l'argomento delle convinzioni politiche di Hammett, ma la verità è che ignoro se sia mai stato iscritto al partito comunista, né mai glielo chiesi. Se questa può sembrare, tra due individui, una strana forma di assenteismo, in realtà noi non la sentivamo tale; probabilmente era il prodotto diretto dei tempi che attraversavamo e d'un riserbo tacitamente convenuto. Riandando al passato, adesso, mi pare che quel nostro riserbo avesse strane regole, diverse da quelle adottate dagli altri. Per esempio, non parlavamo mai di danaro, di quanto costasse una cosa o quanto rendesse quell'altra, sebbene ognuno di noi, in tutti quegli anni, passasse sempre all'altro quello di cui aveva bisogno. Ai miei occhi, il fatto di ignorare se Hammett fosse o no iscritto al partito comunista non ha nessuna importanza; certamente era un marxista, ma un marxista con un gran senso critico, e arrivava a disprezzare l'Unione Sovietica con la stessa provinciale intensità con cui molti americani disprezzavano i paesi stranieri. Era spesso arguto e mordace a proposito del partito comunista americano, nei cui confronti, tuttavia, fu sempre leale. Una volta, durante una discussione, mi disse che moltissimi aspetti del comunismo naturalmente lo preoccupavano e lo avevano sempre preoccupato, e che, se avesse trovato qualcosa di meglio sarebbe stato pronto a cambiare le sue opinioni politiche; poi aggiunse: "E ora, per piacere, non parliamone più, perché ci facciamo del male a vicenda". E non ne parlammo più; ma immagino che anche il non parlarne ci facesse del male e scavasse un solco troppo profondo, ma era sempre meglio delle discussioni che avevamo avuto a partire dal 1940, quando lui aveva capito che non lo avrei seguito sulla sua strada. Credo che ne dovesse provare dolore, ma non lo ammise mai. Ne provavo anch'io, ma sapevo che, a differenza di molti radicali, la sua fede e le sue conclusioni, quali che fossero, erano dovute a tutte quelle letture e a tutto quel meditare. Gli ci voleva tempo per capire come veramente la pensava, ed era di mente aperta e tollerante per natura.
 Hammett apparteneva a una generazione di scrittori geniali. Quelli che conoscevo io erano romanticamente fieri della loro condizione di scrittori: essere scrittori era una gran cosa, allora, forse la migliore, e la si pagava con i sacrifìci. Immagino che desiderassero e fama e danaro quanto gli scrittori di oggi, ma non credo che il bisogno morboso fosse altrettanto radicato, il veleno altrettanto forte. Aspiravano a far danaro, ovviamente, ma non in concorrenza con mercanti e banchieri, e, se investivano il proprio talento, non lo consideravano un capitale con tanto d'interessi. Quando conobbi Dash, erano i tempi in cui si sprecava tra le festicciole hollywoodiane e i bar newyorkesi: e forse quel suo sprecarsi non era meno dannoso, ma certamente un po' perdonabile, per il solo fatto che quelli che ne profittavano erano personaggi da II giorno della locusta. Eppure si rendeva conto di quanto gli stava succedendo, tanto che dopo il 1948 non gli capitò più. Vorrei toroprio poter dire che il mutare della sua vita aumentò la sua produttività, ma non fu così. Forse vigore e forza s'erano dispersi, erano stati dissipati. E, tuttavia, per buona cosa che sia, la produttività non è l'unica testimonianza d'una vita seria: allora, più che mai prima, Dash si diede alla lettura. Leggeva tutto su tutto. Non gli piacevano gli scrittori - in genere, non soffriva né di simpatie né di antipatie - ma, quelli buoni, non li invidiava, e con tutti era benevolo, forse perché ricordava le sue lotte dei primi anni. Hammett apparteneva a una generazione di scrittori geniali. Quelli che conoscevo io erano romanticamente fieri della loro condizione di scrittori: essere scrittori era una gran cosa, allora, forse la migliore, e la si pagava con i sacrifìci. Immagino che desiderassero e fama e danaro quanto gli scrittori di oggi, ma non credo che il bisogno morboso fosse altrettanto radicato, il veleno altrettanto forte. Aspiravano a far danaro, ovviamente, ma non in concorrenza con mercanti e banchieri, e, se investivano il proprio talento, non lo consideravano un capitale con tanto d'interessi. Quando conobbi Dash, erano i tempi in cui si sprecava tra le festicciole hollywoodiane e i bar newyorkesi: e forse quel suo sprecarsi non era meno dannoso, ma certamente un po' perdonabile, per il solo fatto che quelli che ne profittavano erano personaggi da II giorno della locusta. Eppure si rendeva conto di quanto gli stava succedendo, tanto che dopo il 1948 non gli capitò più. Vorrei toroprio poter dire che il mutare della sua vita aumentò la sua produttività, ma non fu così. Forse vigore e forza s'erano dispersi, erano stati dissipati. E, tuttavia, per buona cosa che sia, la produttività non è l'unica testimonianza d'una vita seria: allora, più che mai prima, Dash si diede alla lettura. Leggeva tutto su tutto. Non gli piacevano gli scrittori - in genere, non soffriva né di simpatie né di antipatie - ma, quelli buoni, non li invidiava, e con tutti era benevolo, forse perché ricordava le sue lotte dei primi anni.
Non so quando e come decise di mettersi a scrivere, ma so che scriveva già, dopo aver lasciato il sanatorio militare, nel 1920, quando andò a stabilirsi con la moglie e la figlia - e avrebbe avuto poi un'altra figlia - a San Francisco. (Tornò a lavorare per breve tempo alla Pinkerton, ma non sono sicura se in quegli anni o dopo.) Una volta, gli chiesi perché non avesse mai voluto andare in Europa, perché non avesse mai desiderato visitare altri paesi, allora mi raccontò che un tempo aveva desiderato andare in Australia, magari per stabilirvisi, ma che il giorno in cui aveva deciso di lasciare per sempre la Pinkerton aveva anche deciso di rinunciare per sempre all'idea dell'Australia. Una nave australiana, in rotta da Sidney a San Francisco con un carico di duecentomila dollari in oro, avvertì l'ufficio di San Francisco della compagnia d'assicurazione che l'oro era scomparso. La compagnia d'assicurazione era cliente della Pinkerton, e così Hammett e un altro agente salirono a bordo appena la nave attraccò, interrogarono marinai e ufficiali, perquisirono da cima a fondo la nave, ma non riuscirono a trovare l'oro. Era sicuro che l'oro doveva ancora trovarsi a bordo, e pertanto l'agenzia decise che, quando la nave fosse salpata per tornare in patria, Hammett sarebbe partito anche lui. Felicissimo alla prospettiva di andare gratuitamente là dove aveva sempre sognato d'andare, Dash fece le valigie. Ma, poche ora prima della partenza, il direttore dell'agenzia propose di fare un'ultima perquisizione: Hammett s'arrampicò su una delle ciminiere, sulla quale s'era già arrampicato parecchie volte, guardò giù e gridò: "L'hanno spostato. È qui". Disse che, nell'atto stesso di pronunciare quelle parole, pensò: "Non hai cervello nemmeno per fare il detective. Non potevi scoprirlo dopo un giorno di navigazione?" Tirò fuori l'oro, lo portò all'ufficio della Pinkerton e nel pomeriggio diede le dimissioni.
Seguì una serie di svariati lavori, ma non ricordo quali, anche se me li disse. Dopo un anno o più, la tubercolosi riprese, e con essa le emorragie. Era deciso a non tornare in un sanatorio militare e, convinto di avere ancora pochi anni di vita, stabilì di viverli come aveva sempre desiderato: si allontanò dalla moglie e dai figli, si cibò di brodi e cominciò a scrivere. Un giorno le emorragie cessarono, per non più riapparire, e in quel periodo cominciò a guadagnare qualcosa saltuariamente, scrivendo per riviste popolari - le pulp magazines - e per rubriche sui giornali, e persino vendendo poesie allo "Smart Set" di Mencken. Non tutto m'è chiaro di questo periodo della vita di Hammett, ma, mi risultava, ricordo, abbastanza simpatico, libero bohémien tipo 1920: la ragazza di Pine Street e l'altra di Grant Street e il buon cibo dei piccoli ristoranti di San Francisco e il vino rosso italiano e la notorietà sulle pulp magazines e, allora e forse anche ora, un mondo tutto suo.
18 luglio 1965
Ora che scrivo questi ricordi di Hammett è estate. Forse per questo quasi tutto quello che ricordo di lui ha a che vedere con l'estate, sebbene noi, come tutti quelli che vivono in campagna, fossimo molto più vicini in inverno. Per me l'inverno era stagione di lavoro e, se Hammett era presente nella stanza, io lavoravo meglio. Stava lì, sta lì - chiudo gli occhi e rivedo un'altra cosa: legge II giardino d'autunno. Naturalmente, quando lo guardavo m'innervosivo. Era stato sempre molto critico e io ci ero abituata, anzi lo desideravo, ma adesso avvertivo qualcosa di nuovo ed ero sulle spine. Terminò di leggere la commedia, attraversò la stanza, mi depose in grembo il dattiloscritto, tornò alla sua sedia e cominciò a parlare. Non la solita critica: questa volta fu pungente e stizzoso, pieno di acredine. Parlava come se lo avessi tradito. Fu un tale colpo per me, un tale dolore, che avrei dimenticato volentieri quella scena, non la ricorderei proprio se non fosse per un diario che tenevo per ogni mia commedia. Disse: "Hai cominciato come una scrittrice seria, ed era questo che mi piaceva, a questo m'ero dedicato. Non so cosa sia successo, ma strappala, buttala via. È peggio che cattiva, è mediocre". Mi guardò, sprezzante, e io fuggii da quella stanza, me ne andai a New York e non tornai per una settimana. Quando tornai, avevo strappato la commedia; misi i fogli strappati in una valigetta e la lasciai davanti alla sua porta. Non parlammo più della commedia fino a sette mesi dopo, quando la riscrissi. Non ero più nervosa mentre lui la leggeva; ero troppo stanca per curarmene, e mi misi a dormire sul divano. Mi svegliai perché Hammett stava seduto accanto a me e mi carezzava i capelli, mi sorrideva e annuiva. Dopo che ebbe scosso la testa per un bel po', dissi: "Cosa ti prende?..." Rispose: "Sono contento, perché è la migliore commedia che sia stata scritta da parecchio tempo. Forse da moltissimo tempo. È un bel giorno questo. Un bel giorno". E anche questo fu un colpo per me, perché non gli avevo mai sentito prima tanto entusiasmo; fu un tale colpo che mi avviai verso la porta per andare a prendere un po' d'aria. Mi chiamò: "Ehi, torna indietro. C'è una battuta che non va nell'ultimo atto. Riscrivila". Dissi che non l'avrei riscritta. Rispose che, okay, l'avrebbe fatto lui: e la riscrisse, ci lavorò sopra tutta la notte.
Quando iniziarono le prove del Giardino d'autunno, Dash era presente quasi ogni giorno, turbato ancor più di me dal fatto che alla commedia stava succedendo qualcosa, si stava svuotando; ma questo può succedere e succede sulla scena, e, una volta che è successo, di rado si può riparare.
Ieri ho letto tre lettere che lui scrisse a un amico: parlano delle sue speranze per la commedia, delle prove e della prima. Grandissima era la sua preoccupazione per me e per la commedia, ma col tempo imparai che era buono e sensibile con tutti gli scrittori che gli si rivolgevano per aiuto, e che forse la sua generosità aveva a che vedere più con lo scrivere e la fatica e le pene dello scrivere che con gli autori in sé e per sé. Avevo conosciuto quella generosità già da tempo, naturalmente; ma generosità e sregolatezza si accompagnano sempre, e mi ci volle molto tempo per imparare a distinguerle.
Pochi anni dopo aver conosciuto Dash, le belle somme guadagnate a Hollywood se ne erano andate, sperperate, spese per me che non volevo e per altre che volevano. Forse Hammett è l'unica persona da me conosciuta che non si sia mai curata del danaro, non si sia mai lamentata, né abbia mai avuto rimpianti. Forse per quasi tutti noi il danaro è qualcosa di irreale, più facile da buttar via di quanto veramente ci sta a cuore - ma allora questo non
Io sapevo, e forse lo confusi con la sregolatezza e l'ostentazione. Un giorno, anni dopo, in un periodo in cui per farlo dovette rinunciare ad altre cose, Hammett si comprò una balestra molto costosa.
Il giorno in cui gli arrivò, e lui la stava provando tutto contento ed eccitato, vennero a trovarci due amici con il loro figlio di dieci anni. Dash e il ragazzo passarono l'intero pomeriggio a giocare con la balestra; quando fu il momento d'andare via, il ragazzo fece una faccia tristissima: Hammett allora aprì lo sportello della macchina, ci cacciò dentro la balestra e se ne tornò di corsa in casa, respingendo tutte le proteste dei nostri amici. Quando se ne furono andati, gli dissi: "Era proprio necessario? La desideravi tanto..." Rispose: "II ragazzo la desiderava di più. Le cose appartengono a chi le desidera di più". E, non c'è dubbio, così era andata anche col danaro; e dunque vennero i guai e, all'improvviso, i giorni di digiuno, del fitto non pagato e così via. Sì, vennero i tempi di magra, forse non peggiori di quelli che tanti pure conoscono, ma il contrasto del lunedì senza pranzo e della bisboccia del martedì mi procurava un'irritazione di cui lui non riuscì mai a rendersi conto.
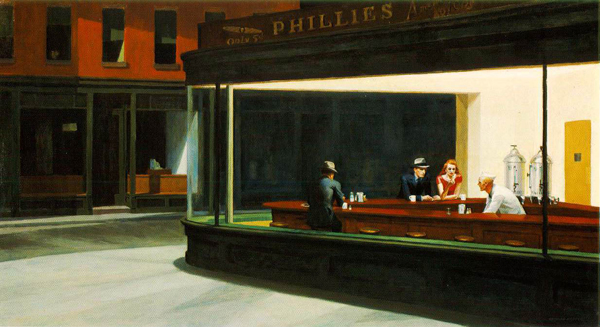 Quando eravamo completamente a terra, nei primi anni a New York, Hammett ricevette un anticipo modesto da Knopf e cominciò a scrivere The Thin Man. Si trasferì in quello che scherzosamente veniva chiamato l'Appartamento Diplomatico di un albergo gestito dal nostro amico Nathanael West. Era un albergo nuovo, ma Pep West e la Depressione erano riusciti a rovinarlo immediatamente. Di certo, l'appartamento di Hammett non aveva mai visto un diplomatico, perché anche il più minuto orientale sarebbe stato a disagio lì dentro; ma il fitto era basso, il mangiare orribile poteva venir messo in conto e buona parte del mio tempo libero potevo passarlo con Pep a ficcare il naso nelle vite degli strambi ospiti. Quando eravamo completamente a terra, nei primi anni a New York, Hammett ricevette un anticipo modesto da Knopf e cominciò a scrivere The Thin Man. Si trasferì in quello che scherzosamente veniva chiamato l'Appartamento Diplomatico di un albergo gestito dal nostro amico Nathanael West. Era un albergo nuovo, ma Pep West e la Depressione erano riusciti a rovinarlo immediatamente. Di certo, l'appartamento di Hammett non aveva mai visto un diplomatico, perché anche il più minuto orientale sarebbe stato a disagio lì dentro; ma il fitto era basso, il mangiare orribile poteva venir messo in conto e buona parte del mio tempo libero potevo passarlo con Pep a ficcare il naso nelle vite degli strambi ospiti.
Avevo conosciuto Dash quando scriveva racconti, ma non ero mai stata presente durante un lavoro più impegnativo: la vita cambiò; niente più bere, niente più compagnie. Era arrivato il momento della clausura e a nessuno fu permesso di disturbarlo finché il libro non fu finito. Non avevo mai visto nessuno lavorare a quel modo: la cura e la preoccupazione per ogni parola, addirittura l'orgoglio per la pagina battuta bene a macchina, il rifiuto, per dieci giorni o due settimane, di uscire fosse anche per una breve passeggiata nel timore che qualcosa andasse disperso. Fu un buon anno per me, e una lezione; e forse ne restai anche un po' impaurila: scoprii che ormai non aveva più bisogno di me. E, dunque, fu un giorno felice quello in cui mi consegnò la prima metà del dattiloscritto da leggere e mi informò che Nora ero io. Era bello leggere di Nora, sposata a Nick Charles, forse uno dei pochi matrimoni nella letteratura d'oggi in cui l'uomo e la donna si vogliono bene e stanno bene insieme. Ma fui subito ridimensionata: Hammett mi disse che ero anche la ragazza stupida del romanzo e la infame. Non saprei dire se scherzasse, allora, comunque mi turbò. Ci tenevo moltissimo a essere giudicata bene da lui. Del resto, non ero sola in questo, una quantità di gente lo desiderava. Parecchi anni dopo, Richard Wilbur confessò che nel momento in cui conobbe Hammett, nello stringergli la mano, la prima cosa che desiderò fu la sua stima. C'è gente che ispira queste cose: Hammett era un esempio. Non so a cosa sia dovuta questa virtù che alcuni hanno: aleggia intorno a loro e non ha nulla a che vedere con le loro opere o il loro operato ma, forse, con una discrezione talmente radicata in loro che tutti si rendono conto di non poterla nemmeno sfiorare con le chiacchiere, le battute, le gentilezze. Il risultato è qualcosa di più che la semplice dignità che traspare dal volto. In carcere, i guardiani chiamavano Hammett "signore" e fuori dal carcere altra gente non si comportava diversamente. Una sera, negli ultimi anni della sua vita, entrando in un ristorante passammo davanti a un gruppo di giovani scrittori che io conoscevo e lui no. Ci fermammo e lo presentai: quei giovanotti baldanzosi si trasformarono immediatamente in rispettosi scolaretti, e, guardandoli in faccia uno per uno, non gli avresti dato più di dieci anni. Dovetti insistere e stuzzicarlo per anni prima che finalmente ammettesse di sapere di quell'impressione che suscitava in molta gente, e mi raccontò così che a quattordici anni, quando era al suo primo lavoro, alla Baltimore and Ohio Railways, per una settimana s'era presentato ogni giorno in ritardo. Il suo superiore gli annunciò che era licenziato. Hammett annuì, disse, e si diresse verso la porta; fu richiamato dal superiore, che gli disse, perplesso: "Se mi da la sua parola che non succede più, le rido il posto". Hammett rispose: "Grazie, ma non posso promettere". Dopo un attimo di silenzio, l'altro disse: "Okay, glielo rido lo stesso". Dash aggiunse di non sapere cosa ci fosse di giusto in quello che faceva, sapeva però che gli sarebbe sempre stato utile.
Quando The Thin Man fu venduto a una rivista - quasi tutte le più grandi e importanti riviste lo avevano respinto giudicandolo troppo audace, sebbene fosse difficile capire cosa intendessero per audace - lasciammo New York in gran fretta. Dopo qualche paio di settimane di sbornie a Miami, ci trasferimmo in una delle Keys, in un semplice villaggio di pescatori, e lì rimanemmo per tutta la primavera e l'estate, pescando il giorno, leggendo la sera. Fu un anno meraviglioso: scoprimmo che andavamo molto d'accordo lontani dalla gente, e anche dalla città.
Come molti meridionali, Hammett amava i luoghi isolati, gli animali, gli uccelli, gli insetti e la loro musica. Ci sapeva fare nella boscaglia, era un bravo tiratore e in seguito, quando io comprai una fattoria, lui passava l'autunno nei boschi, tornando con uccelli o lepri e poi, quando la stagione della caccia era chiusa, d'inverno, passava giorni e giorni seduto su uno sgabello nel bosco a guardare gli scoiattoli, i castori e i cervi, o pescando nei buchi del ghiaccio del lago - come tutti gli innamorati dello sport, era pignolo fino alla noia con gli attrezzi, e disordinato fino all'esasperazione in tutto il resto. La curiosità e l'interesse del giorno continuavano la sera, quando leggeva II mondo e il linguaggio delle api o I fabbricanti d'armi tedeschi del diciottesimo secolo o qualcosa sull'arte di fare i nodi o sugli uccelli di terraferma, abbandonando poi un libro per un altro su quello che aveva successivamente deciso d'imparare. Mi sarebbe impossibile ricordare adesso tutto quello che di volta in volta decideva d'imparare, ricordo però un lungo anno di studio sulla retina dell'occhio, poi: come giocare a scacchi a memoria, le saghe islandesi, la storia delle tartarughe d'acqua dolce, Hegel, l'utilità d'un certo apparecchio acustico - ne aveva comprato uno ottimo - per captare il canto degli uccelli; poi da Hegel, naturalmente, a Marx e Engels, da cima a fondo; e la vita animale sulla costa dell'Atlantico e infine, per tutto il resto della vita, la matematica. Alla matematica s'interessò più che a tutto il resto, a parte il baseball; quando seguiva le partite per radio o televisione, brontolava contro i giocatori, con me che non distinguo una palla da una mazza. Spesso gli dicevo di smetterla, al che lui scuoteva il capo e replicava: "Io non chiedevo altro che una donna remissiva, e guarda chi mi capita" e continuava a parlare della remissività e di quanto poco bastasse a contentarlo, sostenendo che soltanto i fatui e i nevrotici hanno bisogno del "tipo" nella donna: tutti gli altri uomini si contentano di quel che gli capita.
Quel piglia-e-lascia libri, quel saltare da una lettura all'altra, erano possibili solo a una mente non comune, precisa, acuta, rispettosa solo di quello che si può dimostrare. Prese in forte e durevole antipatia una tale che sosteneva che lo sgombro appartiene alla stessa famiglia dell'aringa; una volta, a casa mia, abbandonò la stanza, quando un famoso scrittore attaccò a parlare, senza molta cognizione, dell'esistenzialismo, rifiutandosi poi di scendere a pranzo perché: "Quell'individuo è quanto di più noioso ci sia, dopo il gioco dell'oca. I bugiardi rappresentano una perdita di tempo". Un vicino venne a chiedergli come fare per fermare una perdita d'acqua nella piscina: lo sapeva; il figlio del mio fattore gli chiese come costruire una trappola per tartarughe d'acqua dolce, e sapeva anche questo; cattolico del Maryland - ma aveva abbandonato da un pezzo la chiesa - sapeva molto più di me sul giudaismo, e più di mio padre, che c'era cresciuto, sulla musica, la cucina e l'architettura di New Orleans; un giorno dovevo informarmi sui primissimi metodi di fabbricazione dei vetri per finestre e stavo per consultare l'enciclopedia: mi disse tutto prima che la prendessi in mano. Conosceva la varietà delle alghe marine, per un mese studiò l'impollinazione nelle anemofile e per molti, moltissimi mesi si cimentò con la fisica dei gas. Non era un uomo che leggeva: era un uomo al lavoro. Tutti i libri andavano bene, o quasi tutti - e si mostrava impaziente quando leggevo letteratura o critica e li chiamava, libri "da passeggio": "buoni soltanto a reggerti come un bastone quando sali le scale per andartene a letto". Questa sua passione per i libri, e quel suo disinteresse per gli autori, mi risultava sempre strana - aveva, ovviamente, le sue brave eccezioni: gli piaceva Faulkner, e durante le permanenze di questi a New York, negli anni trenta, passammo insieme intere serate a bere e a discutere. Ma sarebbe più esatto dire che se l'intendeva anche con gli scrittori, quando parlavano di libri; salvo a piantarli quando non ne parlavano. La pittura lo commuoveva profondamente: si dilettò anche a dipingere, fino all'estate in cui non resse più a stare in piedi davanti al cavalletto - e la nostra ultimissima passeggiata insieme, un solo isolato, fu fino al Metropolitan Museum; e amava la musica. Ma non ricordo un solo pittore o un solo musicista che gli piacesse personalmente; ricordo, invece, quanto diceva di loro: che erano, quasi tutti, vanitosi. Non era mai spietato con i semplici, ma sempre impaziente, troppo, con la gente famosa.
Esiste chi è capace d'essere felice sotto le armi, naturalmente; io, però, non avevo mai conosciuto né voluto conoscere nessuno che lo fosse: fu dunque un vero colpo per me quando, nel 1942, scoprii che Hammett era uno di loro. Non riesco a capire come mai un uomo eccentrico che, a differenza della maggioranza degli americani, viveva secondo un proprio stile di vita potesse trovare piacevoli e divertenti le restrizioni, la disciplina e la fatica della vita militare. Chissà, forse in tal modo, in una vita retta e regolata da altri, alcuni problemi venivano a essere risolti; non sopportando la gente, riusciva così a trovare un posto in mezzo agli altri; forse gli dava un senso d'orgoglio il fatto di riuscire ancora a competere a quarantott'anni con uomini che avevano la metà dei suoi anni; chissà, forse era per tutti questi motivi o forse semplicemente perché amava il suo paese e riteneva che la guerra andasse combattuta. Quali che fossero i motivi, sta di fatto che lo squallore delle isole Aleutine non fu tale ai suoi occhi. Ho tante lettere in cui ne descrive la bellezza, e per anni parlò di ritornarci, di andare a rivederle. Vi svolse un corso d'addestramento, e pubblicò ottimi giornali, sotto le armi: l'impaginazione era nitida, le notizie erano precise, le battute divertenti. Divenne una specie di leggenda tra i soldati dislocati tra l'Alasca e le Aleutine. Ho parlato con molti di quelli che furono con lui, e di uno conservo una lettera:
Ero un ragazzo allora. Tutti lo eravamo. Il posto era orrendo, ma c'era Hammett, che quando arrivai io alcuni chiamavano Pop e altri Grand-pop, redattore del giornale, con più ascendente su tutti noi, più capacità d'intimorirci, in un certo senso, che il colonnello - e son convinto che intimorisse anche lui... Ricordo come fosse ieri, entravamo nella baracca vociando e lamentandoci; lui era lì nella sua branda a leggere, staccava gli occhi dalla pagina e sorrideva, e noi tutti stavamo zitti. Nessuno s'avvicinava alla branda, nessuno lo disturbava. Quando s'aveva bisogno di soldi o d'aiuto e lui veniva a saperlo era sempre lì, pronto. Pagò la licenza e il matrimonio d'uno dei ragazzi; quando un altro di noi "appese" uno spaventoso conto al bar di Nome lui diede i soldi per pagarlo al ragazzo che puliva i gabinetti a Nome, dicendogli che, se qualche commilitone avesse fatto domande, doveva rispondere che era il suo conto... Un bel po' di noi non si limitavano a lamentarsi: quasi impazzivano, a momenti. E come era possibile non impazzire, in un luogo orrendo con un tempo orrendo? Neppure l'ombra della guerra e sempre uragani, e dovevi trascinarti alle latrine carponi, perché, se t'alzavi in piedi il vento ti trasportava fino in Siberia, e un programma di divertimenti che andavano da Olivia De Havilland ai dischi di W. H. Auden. Ma il chiodo fisso erano le donne. Dopo un anno che eri lì, ti sentivi fare ogni genere di racconti su quello che ti capita a star senza donne. Ricordo intere notti passate a chiacchierare nella nostra baracca sui pericoli del celibato. Hammett ascoltava per un po', sorrideva, poi riprendeva a leggere o, se parlavamo a voce alta, sospirava e si metteva a dormire - per via del giornale, la sua giornata di lavoro cominciava intorno alle due del mattino. Una notte che la chiacchierata si tramutò in un vocio scatenato e uno dei ragazzi prese addirittura a strillare, Hammett s'alzò dalla branda per andarsene direttamente a lavorare. Il ragazzo strillò : "Tu che ne pensi, Pop? E dì qualcosa!" Hammett rispose: "Okay, sarebbe bello avere una donna; ma non averla non ti fa certo cadere i capelli e i denti, e, se impazzisci, saresti impazzito lo stesso, e se voi ragazzi non la piantate con questa storia io me ne vado, mi trasferisco in un'altra baracca. Sotto la mia branda c'è una bottiglia di scotch, bevetela e andate a dormire". E se ne andò a lavorare. Fu tale la paura di perderlo che non sfiorammo più l'argomento davanti a lui...
Ma, come ho detto, gli anni subito dopo la guerra, dal 1945 al 1948, furono brutti anni. Il bere aumentò, ancora più sregolato, e affiorò un certo smarrimento, una negligenza che non avevo mai visto prima. Capii così che dovevo andarmene per la mia strada. Non che ci fossimo lasciati, ma ci vedevamo meno, eravamo meno intimi. E, tuttavia, anche in quegli anni ci furono ancora giorni meravigliosi, lì alla fattoria, con la caccia autunnale e i pasticci d'orzo selvatico e la preparazione delle salsicce e tutti i libri che lui leggeva mentre io cominciavo a scrivere una nuova commedia. Ancora lo vedo: si alzava per andare a mettere un ceppo sul fuoco e veniva da me a scuotermi. Io dicevo sempre, puntualmente: "Non stavo dormendo, stavo pensando..." Al che, ridendo, rispondeva: "Certo, certo. Dormivi da un'ora, ma un sacco di gente pensa meglio quando dorme, e tu sei una di loro".
Nel 1952 dovetti vendere la fattoria. Mi trasferii a New York e Dash prese in affitto una casetta a Katonah. Andavo a trovarlo una volta la settimana e una volta la settimana veniva lui a New York, e ci telefonavamo ogni giorno. Però voleva star solo, o così credevo allora; ora invece non ne sono più tanto sicura, perché ho imparato che gli uomini orgogliosi che non chiedono niente saranno ottimi tipi nella vita e nei romanzi, ma nella realtà son gente difficile a viverci insieme e a capirli. In ogni modo, col passare degli anni divenne un eremita e il piccolo e brutto cottage di campagna divenne ancora più brutto e più piccolo, con pile di libri su ogni sedia e nessun posto dove sedersi, e uno strato alto due palmi di posta inevasa sulla scrivania. Dappertutto, i segni della malattia: il grammofono trascurato, la macchina da scrivere abbandonata, i suoi adorati e strambi oggetti ancora incartati, intatti. Quando andavo a trovarlo ogni settimana, non parlavamo molto, e, quando veniva lui a trovare me ogni settimana, era troppo stracco per il breve viaggio.
Forse impiegai troppo tempo per capire che non poteva più vivere solo, e, anche quando l'ebbi capito, non seppi come dirlo. Un giorno, subito dopo che mi ebbe costretta a promettergli di smettere di leggere LiI Abner, mentre ancora ridevo per il suo impeto e ardore, all'improvviso apparve imbarazzato - appariva puntualmente imbarazzato quando doveva dire qualcosa che poteva far male - e disse: "Non posso più vivere solo. Sto peggiorando. Me ne torno in un sanatorio militare. Andrà tutto bene, continueremo a vederci. E non voglio lacrime". Invece ci furono lacrime, due giorni di lacrime alla fine dei quali acconsentì a venire a stare da me. Ancora adesso, mentre scrivo queste pagine, il fatto che volesse sempre fare le cose a modo suo mi stizzisce e insieme diverte: un attimo fa ho abbandonato la macchina da scrivere e l'ho assalito come se potesse sentirmi. M'intendo poco di amori romantici, poco come quando avevo diciott'anni, ma so, conosco il profondo piacere che da l'interesse continuo, l'eccitante curiosità di sapere cosa pensa l'altro, cosa farà, cosa non farà, le manie soddisfatte e insoddisfatte, il sottile spago che gli anni trasformano in corda che, nel mio caso, è lì appesa, oscillante, così rimasta dopo tanto tempo dalla sua morte. Non so che cosa penserebbe Hammett del resto di questi appunti su di lui, sono però sicura che, nel suo fraintendimento, si compiacerebbe della stizza che provo oggi per lui. E così visse con me gli ultimi quattro anni della sua vita. Non fu sempre facile, certi momenti furono molto brutti, ma l'esserci incontrati tant'anni prima e aver rovinato molto e riparato poco e tuttavia aver retto insieme, era certo un piacere inesprimibile. Però a volte la nostra riservatezza, di rado infranta, mi irritava e, presentendo che la morte non era lontana, cercavo qualcosa che mi restasse; così un giorno gli chiesi: "Siamo stati benissimo insieme, vero?..." Rispose: "Benissimo è una parola troppo grossa, per me. Diciamo che siamo stati meglio di tanti altri, non ti pare?"
 La vigilia del Capodanno 1960 lasciai Hammett affidato alle cure di un'infermiera simpatica ed esperta, e andai a passare alcune ore a casa di amici. Da lì andai via a mezzanotte e mezzo; l'infermiera mi telefonò inutilmente pochi minuti dopo. Quando entrai nella stanza di Hammett, stava seduto alla sua scrivania con la faccia tesa ed eccitata che aveva al tempo in cui beveva. In grembo aveva un grosso volume stampato in giapponese che aveva comprato e amato molti anni prima. Stava indicando col dito un ideogramma e chiedeva intanto all'infermiera: "Guarda, cara, non è meraviglioso?" Quando mi avvicinai, l'infermiera fece per allontanarsi, ma lui le prese la mano e gliela baciò, con lo stesso gesto elegante e civettuolo d'un tempo; poi guardò me e ammiccò. Il libro era capovolto, e, dunque, era inutile che l'infermiera brontolasse quella parola: "dissociato". Da allora in poi - lo portammo all'ospedale la mattina dopo - mi son sempre rifiutata di sapere cosa veramente significhi dissociato. Hammett rifiutò ogni cura, ogni assistenza di medici e di infermiere, con una specie di ostinata e misteriosa ritrosia. Prima di quella sera del libro capovolto, avevamo deciso di trasferirci a Cambridge perché avevo ottenuto una cattedra: il libro capovolto avrebbe dovuto farmi capire che la fine era giunta, invece mi rifiutavo alla sola idea, e così volai a Cambridge, trovai una clinica per Dash, e tornai in aereo la sera stessa a dirglielo. Rispose: "Ma come facciamo ad arrivare a Boston?" Gli dissi che avremmo preso un'ambulanza e, per la prima volta in vita sua, credo, lui osservò: "Costerà troppo". Replicai: "In tal caso prenderemo un carro da pionieri..." Sorrise e disse: "Forse è il mezzo con cui ci saremmo dovuti sempre spostare". E così mi sentii meglio quella notte, sicura di un rinvio. Sbagliavo. Prima delle sei del mattino mi chiamarono dall'ospedale: Hammett era in coma. Quando entrai nella stanza e mi avvicinai al suo letto, ci fu un ultimo segno di vita: aprì gli occhi, parve molto sorpreso e cercò di sollevare il capo. Ma non doveva mai più riprendere conoscenza e morì due giorni dopo. La vigilia del Capodanno 1960 lasciai Hammett affidato alle cure di un'infermiera simpatica ed esperta, e andai a passare alcune ore a casa di amici. Da lì andai via a mezzanotte e mezzo; l'infermiera mi telefonò inutilmente pochi minuti dopo. Quando entrai nella stanza di Hammett, stava seduto alla sua scrivania con la faccia tesa ed eccitata che aveva al tempo in cui beveva. In grembo aveva un grosso volume stampato in giapponese che aveva comprato e amato molti anni prima. Stava indicando col dito un ideogramma e chiedeva intanto all'infermiera: "Guarda, cara, non è meraviglioso?" Quando mi avvicinai, l'infermiera fece per allontanarsi, ma lui le prese la mano e gliela baciò, con lo stesso gesto elegante e civettuolo d'un tempo; poi guardò me e ammiccò. Il libro era capovolto, e, dunque, era inutile che l'infermiera brontolasse quella parola: "dissociato". Da allora in poi - lo portammo all'ospedale la mattina dopo - mi son sempre rifiutata di sapere cosa veramente significhi dissociato. Hammett rifiutò ogni cura, ogni assistenza di medici e di infermiere, con una specie di ostinata e misteriosa ritrosia. Prima di quella sera del libro capovolto, avevamo deciso di trasferirci a Cambridge perché avevo ottenuto una cattedra: il libro capovolto avrebbe dovuto farmi capire che la fine era giunta, invece mi rifiutavo alla sola idea, e così volai a Cambridge, trovai una clinica per Dash, e tornai in aereo la sera stessa a dirglielo. Rispose: "Ma come facciamo ad arrivare a Boston?" Gli dissi che avremmo preso un'ambulanza e, per la prima volta in vita sua, credo, lui osservò: "Costerà troppo". Replicai: "In tal caso prenderemo un carro da pionieri..." Sorrise e disse: "Forse è il mezzo con cui ci saremmo dovuti sempre spostare". E così mi sentii meglio quella notte, sicura di un rinvio. Sbagliavo. Prima delle sei del mattino mi chiamarono dall'ospedale: Hammett era in coma. Quando entrai nella stanza e mi avvicinai al suo letto, ci fu un ultimo segno di vita: aprì gli occhi, parve molto sorpreso e cercò di sollevare il capo. Ma non doveva mai più riprendere conoscenza e morì due giorni dopo.
da: Lilian Hellman, Un amico, un certo Hammett, introduzione a Dashiell Hammett, L'istinto della caccia, Mondadori, 1967
|