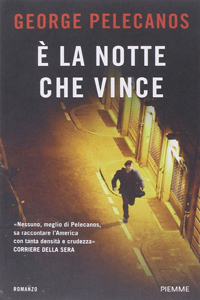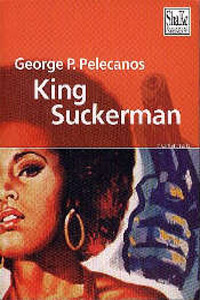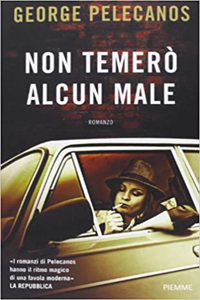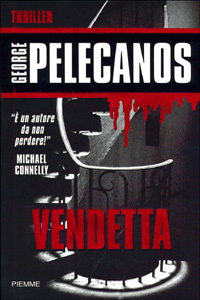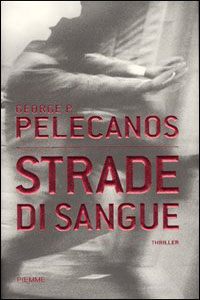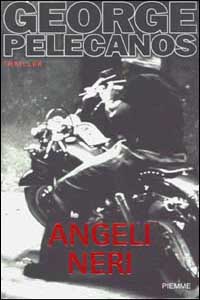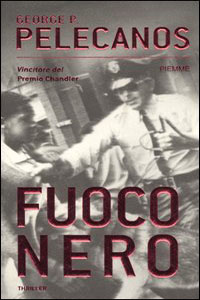Qualche anno fa il Guardian lo definì «Street writing man», ma George Pelecanos non è soltanto uno degli autori statunitensi che meglio ha saputo tradurre il linguaggio e la vita della strada prima in una lunga serie di importanti romanzi e quindi in serie tv di enorme successo. A sessantaquattro anni questo figlio di immigrati greci cresciuto nei quartieri afroamericani di Washington, è forse lo scrittore che ha affrontato con maggiore coinvolgimento personale e profonda e reale umanità non solo il mondo del crimine e tutti i suoi protagonisti, ma lo spaccato terribile della società americana che questo rivela implacabilmente. La traccia di Pelecanos nel profondo rinnovamento della narrativa noir è da questo punto di vista imprescindibile, anche se spesso sottaciuta. Mentre è sotto gli occhi di tutti il suo contributo, da sceneggiatore, al nuovo racconto urbano che si sta incarnando nelle serie tv, dalla celebre The Wire, a The Deuce, sull’industria del porno nella New York degli anni ’70, e Treme, sulla vita degli abitanti dell’omonimo quartiere nero di New Orleans dopo l’uragano Katrina.
La profonda empatia che caratterizza da sempre l’approccio dello scrittore alla crime novel è ora riaffermata dai racconti riuniti nella raccolta Martini shot (Sem, pp. 262, euro 18, traduzione di Giovanni Zucca), pubblicati in una pausa del lavoro per la tv, dove con la scusa del noir è un intero catalogo di sconfitte e speranze tradite, di ricerca dell’amore e di sogni infranti che scorre davanti ai nostri occhi. Ma se i personaggi che popolano queste pagine possono essere descritti come dei perdenti, lo sono senza rinunciare fino all’ultimo minuto alla loro irriducibile umanità. E forse non a caso in mezzo alle loro storie Pelecanos stesso sceglie di raccontare qualcosa di sé.
Si ha l’impressione che questi racconti indaghino prima di tutto il ruolo che il destino, la voglia di redenzione e i molti rimpianti che gli individui si portano dietro possono giocare nelle vite di ciascuno. Qual è il filo che li lega? Credo che a fare da filo conduttore tra i diversi racconti sia il desiderio di appartenere a qualcosa. Anche per gli outsider e i «freaks» ciò è possibile. Penso a cose come la ricerca dell’amicizia o dell’amore. Da questo punto di vista, in ogni scena che scrivo, c’è qualcuno in qualche modo impegnato in questa ricerca. Così, ne «L’informatore» è il bisogno universale di un figlio di ottenere l’affetto di suo padre che suggella il destino del protagonista, mentre per l’immigrato che è al centro della vicenda narrata ne «La morte negli occhi» è l’incontro e poi la perdita di un amico a determinare tutto: siamo negli anni Trenta e lui è un greco arrivato in America tra mille difficoltà ed è completamente solo. Quando l’unico amico che si era fatto viene ucciso, anche lui sarà disposto a commettere un atto violento per vendicarlo.
In uno dei racconti, «Scelto», si coglie l’eco di qualcosa che la riguarda da vicino: il protagonista è figlio di immigrati greci e adotta diversi bambini, proprio come ha fatto lei. Uno di questi, Spero (Lucas), diventerà detective e sarà protagonista del romanzo «The Cut» (2011). La relazione con i suoi personaggi è tale che diventano delle figure famigliari? Senza alcun dubbio. Credo profondamente nel mondo che ho creato e che i miei personaggi siano sempre vivi in quel mondo. Ho scritto «Scelto» per cercare di approfondire le radici del personaggio di Spero Lucas che in altre occasioni ho raccontato ma quando era già entrato nell’età adulta. In questo caso mi interessava invece capire lo sviluppo della sua personalità fin da piccolo, ciò che lo avrebbe portato a diventare quello che abbiamo conosciuto in seguito. «Scelto» è il racconto più personale dell’intera raccolta ed è attraversato da molte emozioni intime, il che è insolito per me, almeno in una forma così diretta. Penso di averlo scritto soprattutto per i miei figli.
Nel corso del tempo le sue storie hanno assunto spesso l’aspetto di «reportage urbani», dove ad emergere sono non solo i crimini, ma le condizioni sociali degli abitanti, la vita stessa di un quartiere o di una città. Basti pensare alla zona occidentale di Baltimora nella serie The Wire… In effetti, all’apparenza quella serie sembra essere il classico show poliziesco: poliziotti contro spacciatori di droga in un quartiere di Baltimora. Ma in realtà ad essere descritto è il modo in cui funzionano le cose. Ad ogni stagione abbiamo aggiunto sempre più elementi e personaggi: politici, insegnanti, ragazzi, avvocati, giudici, giornalisti. Alla fine, il risultato è una sorta di visione panoramica di una città americana e un’ipotesi sul perché abbiamo fallito e così tante persone sono scivolate giù attraverso le crepe della società.
L’altro elemento che ritorna nelle sue storie è l’empatia verso i personaggi. La letteratura poliziesca che è spesso accompagnata da una nota di cinismo diventa qui il luogo delle occasioni perdute, dove si è prima di tutto vittime (per condizioni sociali, razzismo, mancanza di stimoli), ma dove non è mai troppo tardi per tentare di cambiare le cose. Molti romanzi polizieschi e la maggior parte delle serie tv del genere sono fascisti. Dicono al lettore o allo spettatore che se commetti un crimine verrai catturato e rinchiuso. Questo tipo di narrativa segue quasi sempre la medesima formula: un crimine, di solito un omicidio, si verifica nel primo capitolo e viene risolto nell’ultimo. Alla fine il mondo si rimette in piedi, rassicurando il lettore che tutto potrà tornare come prima. Ma è solo un inganno. Un omicidio non è mai «risolto» perché la vittima è morta, per sempre, e coloro che ha lasciato dietro di sé saranno altrettanto coinvolti, per sempre. Quando ci pensi, se sei abbastanza coraggioso da pensarci, capisci che non potrà mai esserci alcun lieto fine. Nonostante questo, le persone continuano a lottare, ad andare avanti, come un artista che cerca invano di sconfiggere la morte con le sue opere. Un giorno chiesero a Telly Savalas (il tenente Kojak dell’omonima serie televisiva, ndr) cosa significasse per lui essere greco. Lui rispose: «Sputare in faccia a ciò che è inevitabile». D’accordo, non è Aristotele ma è comunque fantastico.
Lei è stato tra i produttori del documentario «Baltimora Rising» che racconta le proteste seguite all’assoluzione degli agenti coinvolti nella morte di un ragazzo nero, Freddie Gray, nel 2015. Un caso tragicamente simile a tanti altri. Con la recente condanna del poliziotto che ha ucciso George Floyd l’America ha voltato pagina? Credo che le cose stiano iniziando a cambiare. È in atto una sorta di rivoluzione all’interno delle polizia, ma poiché ci troviamo ancora nel bel mezzo di questo processo è difficile coglierne fino in fondo i progressi. La condanna dell’assassino di George Floyd è stato un piccolo passo nella giusta direzione. Cinque anni fa non sarebbe mai successo nulla del genere. Quindi è il segnale che stiamo andando avanti.
«Martini shot», il racconto che dà il titolo alla raccolta, parla di un autore e produttore di serie tv che si trova a dover affrontare nella vita reale una di quelle storie crime che è abituato a scrivere. Finirà per trasformarsi in una sorta di detective per risolvere un «caso», annotando però nel frattempo lo slang della strada che ascolta. Viene da pensare che scrivendolo lei abbia giocato un po’ con il suo lavoro che si divide da tempo tra i romanzi, le serie e il cinema. In effetti quel racconto è stato un po’ il mio modo di provare a fare i conti con tutto questo. I tropi della fiction poliziesca e di un programma televisivo dello stesso genere contro la realtà della strada. Tutte le cose che scrivo si basano su un’accurata documentazione. Sto per iniziare a girare una miniserie per l’Hbo chiamata We Own This City, che si occupa di polizia e corruzione a Baltimora dopo il caso di Freddie Gray e che, per estensione, cerca di rispondere ad alcune domande sulla polizia americana in generale. È un progetto a cui lavoro già da due anni. Una volta iniziato, non sono più soltanto uno scrittore, ma seguo la realizzazione concreta del lavoro ogni giorno. Con una troupe di centinaia di membri ci sono ogni giorno da risolvere un’infinità di questioni. È un po’ più difficile che stare seduto in una stanza da solo a scrivere. Ma mi piace lavorare a stretto contatto con tutta quella gente. E non sto ancora pensando alla pensione.