BREVE STORIA D'ITALIA
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
IL CONGRESSO DI VIENNA
Costruzione delle
basi politiche di una pace duratura, restaurazione dell’assolutismo e liquidazione definitiva della minaccia rivoluzionaria
furono gli obiettivi dei vincitori di Napoleone I, che alla fine del
1814 si riunirono nel Congresso di Vienna e concordarono il nuovo equilibrio
europeo sulla base degli interessi delle principali potenze: Gran Bretagna,
Russia, Austria, Prussia, e la stessa Francia. Naturalmente non venne
tenuto alcun conto delle aspirazioni nazionali emerse fra le popolazioni
e si puntò soprattutto a rispettare il principio di legittimità
dei sovrani spodestati da Napoleone
La Gran Bretagna conservò Malta, acquisì
Ceylon, la colonia del Capo, una parte della Guinea e alcune delle Antille.
L’Austria perse il Belgio, ma ottenne il Lombardo-Veneto,
il Trentino, l’Istria e la Dalmazia. La Prussia
ottenne i territori alla sinistra del Reno, il bacino della Ruhr e una
parte della Sassonia. La Russia conservò la
Finlandia e il protettorato sul ricostituito Regno di Polonia. La Francia mantenne l’integrità del territorio nazionale. La Svezia
incorporò la Norvegia. Il Belgio e l’Olanda formarono il
Regno dei Paesi Bassi sotto Guglielmo I d’Orange
e Nassau. Il dissolto Sacro Romano Impero lasciò il posto alla Confederazione Germanica, che raggruppava trentotto
Stati indipendenti tra i quali la Prussia, la Sassonia, la Baviera.
La Confederazione Svizzera vide da tutti garantita la propria neutralità.
Il Regno di Sardegna, con Vittorio Emanuele I, ebbe
Genova, Nizza e la Savoia, e il resto dell’Italia mantenne la
tradizionale fisionomia monarchica con Ferdinando III di Lorena nel Granducato di Toscana, Maria Luisa d’Asburgo
nel Ducato di Parma e Piacenza, Francesco IV d’Austria
nel Ducato di Modena e Reggio, i Borboni nel Regno
delle Due Sicilie, il papa nello Stato Pontificio.

Il Congresso di Vienna, tuttavia, ancora riunito, rispose mettendo Napoleone al bando dall’Europa e decise l’intervento armato, ma l’imperatore giocò d’anticipo e attaccò gli eserciti alleati di stanza in Belgio: dopo una prima vittoria, il 18 giugno 1815 a Waterloo fu sconfitto dal duca di Wellington, e dopo solo cento giorni riprese la via dell’esilio; fu inviato nella sperduta isola di Sant'Elena, dove morì nel 1821. Luigi XVIII tornò sul trono di Francia.
Con l’Atto finale del giugno 1815 il Congresso di Vienna poté quindi ultimare i propri lavori e, proprio alla luce del colpo di coda di Napoleone, il primo ministro austriaco Klemens Metternich (il grande teorico della controrivoluzione) propose l’introduzione di un principio del tutto nuovo nella storia delle relazioni fra gli Stati: la solidarietà internazionale, secondo forme permanenti di collaborazione che garantissero l’ordine europeo e scongiurassero ogni ipotesi rivoluzionaria. Su proposta dello zar Alessandro I si costituì la Santa Alleanza, che successivamente prese forma ufficiale nella Quadruplice Alleanza tra Russia, Austria, Inghilterra e Prussia. La restaurazione dell’ancien régime era definitivamente compiuta.
TRA ROMANTICISMO E RIVOLUZIONE
Ma se leve del potere era ritornate in mano alle forze più conservatrici, questo equilibrio non era certo destinato a durare a lungo: la nascita dell’industria moderna e la rivoluzione francese avevano infatti prodotto le più grandi e profonde trasformazioni sociali che la storia umana avesse mai visto, e ciò aveva innescato un processo irreversibile di cambiamento, che non poteva essere arrestato dalla restaurazione politica, malgrado questa, paradossalmente, avesse trovato un potente alleato nella cultura romantica.
Sorto in Germania come reazione alla cultura francese dominante, il romanticismo non poté che caratterizzarsi in chiave anti-illuministica: la filosofia idealistica (Fichte, Schelling) contro il sensismo e il materialismo, il progetto di una nuova teocrazia (de Maistre) contro le idee ateistiche e repubblicane, l’esaltazione dei valori cavallereschi (i romanzi di Walter Scott) contro l’egualitarismo, la nostalgia della tradizione medievale e del nazionalismo (Novalis, Schlegel) contro il cosmopolitismo, l’apologia dell’antica saggezza e generosità dei signori feudali contro lo sviluppo capitalistico e le rivendicazioni delle classi subalterne.
Ma già intorno al 1820 queste tendenze culturali reazionarie passarono in secondo piano e la figura dell’intellettuale romantico (simboleggiato da quel lord Byron morto per la libertà della Grecia contro il dominio turco, tant’è che il filoellenismo divenne una caratteristica dominante del movimento romantico) tese a identificarsi con il ribelle insofferente delle censure e dell’autoritarismo, talvolta spinto alla fuga dalla realtà: le opere letterarie dei francesi Lamartine, Madame de Staël, Hugo, Balzac, dell’italiano Leopardi, del russo Puskin, degli inglesi Keats e Shelley; la musica di Beethoven, Schubert, Chopin, e poi di Verdi e Wagner.
La rielaborazione romantica delle idee di libertà manifestate dalla rivoluzione francese trovò terreno fertile non solo nel campo artistico, ma anche in quello del pensiero politico, filosofico e giuridico, orientandosi in due grandi filoni, quello liberale e quello democratico.
Il primo esprimeva in chiave moderata i principi dell’89, rifiutandone gli sbocchi radicali e lo stesso concetto di sovranità popolare, assegnando ai soli “proprietari” il diritto di voto, in quanto i nullatenenti e la stessa piccola borghesia non potevano avere interesse a mantenere l’ordine sociale: tutti dovevano essere uguali di fronte alla giustizia, ma spettava solo a un nucleo piuttosto ristretto di alta borghesia di elaborare le leggi. Sul versante politico Benjamin Constant fu uno dei principali teorici del liberalismo, mentre Adam Smith (La ricchezza delle nazioni, 1776) fornì il massimo contributo di elaborazione nell’ambito dell’economia: l’Inghilterra, avendo per prima sperimentato il sistema produttivo nato con la rivoluzione industriale, era il paese più adatto per lo sviluppo di un nuovo pensiero economico (che sarà poi definito l’economia politica classica), e Smith, appunto, mise al centro del liberalismo l’iniziativa privata, intesa come massima garanzia non solo dello sviluppo materiale, ma anche del progresso civile e della felicità individuale; malgrado questa visione ottimistica dovesse nel secolo successivo essere crudamente smentita dai fatti, tuttavia essa ebbe un ruolo decisivo nel fornire al nascente capitalismo gli strumenti teorici per opporsi efficacemente alle ottuse resistenze dei fautori del vecchio sistema feudale. Accanto a Smith due grandi economisti, sempre inglesi, furono Robert Malthus, che per primo intuì i gravi squilibri che poteva produrre l’incontrollato sviluppo demografico, e David Ricardo, che studiò la tendenza del salario operaio a mantenersi ai livelli minimi di sopravvivenza e le nuove contraddizioni (soprattutto la disoccupazione) causate dall’introduzione delle macchine.
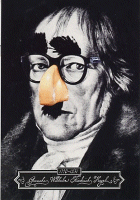 In
Germania il romanticismo conservatore fu più tenace che altrove,
ma si trovò a scontrarsi con la scuola dell’idealismo:
massimo esponente ne fu Georg Friedrich Hegel, che
mise al centro del suo pensiero la dialettica, considerando
la storia umana come un continuo superamento di contraddizioni, mediante
il quale si realizza il progresso; ma, a differenza dei liberali, Hegel
considerava l’agente principale di tale sviluppo non tanto l’individuo
quanto lo Stato, in cui la persona poteva realizzare gli ideali della
razionalità e della moralità: la ricerca del benessere
da parte del singolo acquista quindi validità etica in quanto
“contributo all’appagamento dei bisogni di tutti gli
altri”. Questa funzione preminente dello Stato, che porta
a privilegiare l’interesse generale su quello del singolo, fu
anche assimilata dal pensiero autoritario, ma vi fu una sinistra hegeliana
che, soprattutto con Marx,
diede uno sbocco rivoluzionario a questa teoria.
In
Germania il romanticismo conservatore fu più tenace che altrove,
ma si trovò a scontrarsi con la scuola dell’idealismo:
massimo esponente ne fu Georg Friedrich Hegel, che
mise al centro del suo pensiero la dialettica, considerando
la storia umana come un continuo superamento di contraddizioni, mediante
il quale si realizza il progresso; ma, a differenza dei liberali, Hegel
considerava l’agente principale di tale sviluppo non tanto l’individuo
quanto lo Stato, in cui la persona poteva realizzare gli ideali della
razionalità e della moralità: la ricerca del benessere
da parte del singolo acquista quindi validità etica in quanto
“contributo all’appagamento dei bisogni di tutti gli
altri”. Questa funzione preminente dello Stato, che porta
a privilegiare l’interesse generale su quello del singolo, fu
anche assimilata dal pensiero autoritario, ma vi fu una sinistra hegeliana
che, soprattutto con Marx,
diede uno sbocco rivoluzionario a questa teoria.In Italia il pensiero liberale trovò espressione in due riviste pubblicate a Milano e a Firenze, Il conciliatore fondato da Federico Confalonieri e diretto da Silvio Pellico, e Antologia, di Giampietro Vieusseux e Gino Capponi.
Malgrado il suo taglio nettamente moderato, il liberalismo fu osteggiato aspramente dal potere, che di fatto lo mise sullo stesso piano dell’altra grande corrente, quella democratica, o radicale. I democratici presero dal romanticismo più che l’idea di individuo quella della nazionalità, coniugandola con i principi giacobini (e rousseauiani) di sovranità popolare e di eguaglianza politica: fu questo nesso a dare forza al movimento democratico, e a dare l’impulso fondamentale ai movimenti ostili ai regimi assolutistici.
Ma fra i liberali era troppo netto il rifiuto delle idee giacobine, e i due schieramenti non riuscirono a trovare un terreno d’intesa comune, malgrado il tentativo di mediazione operato da due grandi pensatori: Alexis de Tocqueville, insigne studioso della rivoluzione americana e di quella francese, diffidava sì del regime democratico in quanto società “di massa”, e come tale fonte di conformismo, di annullamento dell’individualità, però non escludeva una progressiva evoluzione del liberalismo verso la democrazia, attraverso una graduale estensione dei diritti politici; l’inglese John Stuart Mill accentuò questa impostazione, ma, ormai nella seconda metà dell’800, il nemico della borghesia non era più il dispotismo monarchico bensì il movimento socialista.
Per sfuggire alla feroce repressione molti gruppi radicali e liberali si organizzarono in Società segrete, che si diffusero in tutti i paesi europei ed ebbero numerosi aderenti sia fra gli intellettuali che fra i giovani ufficiali: la più importante fu senz’altro la Carboneria, e dalla loro attività cospiratoria presero le mosse i tentativi insurrezionali del 1820-1 e del 1830-1: in seguito la loro influenza diminuì nettamente, sia perché dopo il 1830 in Francia e in Inghilterra i regimi usciti dalla rivoluzione del 1830 offrivano la possibilità di organizzarsi legalmente, sia perché ormai era andata profilandosi una terza forza di opposizione all’assolutismo, quella prefigurata da Babeuf e Buonarroti (Congiura degli eguali): all’eguaglianza politica essi avevano contrapposto quella sociale, sostenendo che le garanzie costituzionali non potevano davvero realizzarsi senza un sostanziale mutamento della distribuzione della ricchezza.

In realtà varie furono le correnti del nascente movimento socialista: meno radicale del comunismo agrario teorizzato da Babeuf, il socialismo utopistico delineato da Claude-Henry de Saint-Simon (Nuovo Cristianesimo, 1825), proponeva un patto di solidarietà fra industriali e operai per superare gli aspetti più deteriori del capitalismo ed eliminare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo; ancora più venato di utopia il progetto di Charles Fourier di creare comunità di vita e di lavoro (falansteri) in cui finalmente potesse realizzarsi l’armonia sociale; l’imprenditore americano Robert Owen cercò di realizzare concretamente questa idea, ma il fallimento dell’iniziativa lo portò poi a trasferire il proprio impegno in Inghilterra, dove già operavano nuclei sindacali (le prime Trade Unions) e cooperative di consumo. Tutta questa fase del socialismo utopistico non diede risultati di rilievo, soprattutto perché troppo astratti ne erano i presupposti: aggrapparsi all’idea che fosse una tendenza naturale dell’uomo associarsi e praticare la solidarietà, e che fosse quindi sufficiente proclamare questo principio affinché esso potesse realizzarsi, era evidentemente troppo in contrasto con una società industriale in formazione e nella quale conflitti, egoismi, arretratezza culturale, erano ostacoli difficilmente superabili con una semplice ottica illuministica. Grande fu il ruolo di questi precursori, ma, dopo il 1848, fu solo il socialismo scientifico, basato sull’analisi concreta della realtà concreta, a far uscire le istanze di liberazione degli uomini dal vago ambito filosofico e a organizzarle in movimento di massa.
La Chiesa cattolica esercitò una funzione determinante nell’opera restauratrice (e non a caso il romanticismo conservatore puntò a una forte riscoperta dei valori religiosi), ma anche al suo interno agirono forze orientate in qualche modo al progresso, consapevoli che l’irrigidimento su posizioni reazionarie poteva favorire la rivolta anticlericale: in questo ambito del cattolicesimo liberale ebbero un ruolo importante nella cultura italiana Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti e lo stesso Alessandro Manzoni.
Ancora più sensibile alle suggestioni liberali fu il mondo religioso del cristianesimo riformato: in Inghilterra la spinta al rinnovamento veniva dai settori del clero più legati agli ambienti operai e riacquistò vigore il metodismo predicato a metà ‘700 da John Wesley, da cui poi si svilupparono varie confessioni diffusesi largamente anche negli Stati Uniti. In tutti i paesi protestanti, comunque, ebbe un notevole seguito il pietismo religioso, che tendeva a mettere in pratica le idee umanitaristiche dell’illuminismo, e uno dei principali effetti di questo movimento fu appunto l’abolizione della schiavitù, decisa dapprima in Inghilterra e in seguito negli altri paesi occidentali.
Ecco, quindi, che la situazione politico-culturale europea non era affatto quella, bloccata e immutabile, prospettata dal patto di solidarietà fra le grandi potenze, ma partì dalle colonie il primo segnale, con i movimenti di liberazione nazionali dell’America Latina che misero in crisi il dominio imperiale di Spagna e Portogallo: inevitabile che questi paesi al loro stesso interno fossero investiti dai fermenti di rivolta (1820-1), che toccarono anche l’Italia e la Grecia, fino al tentativo dei decabristi in Russia. Una seconda fase dei moti (1830-4) ebbe l’epicentro in Francia ma coinvolse gran parte dell’Europa.
 Ai primi dell’800 la popolazione delle colonie spagnole raggiungeva i 17 milioni, di cui la metà indios e poi meticci, neri, bianchi e creoli (bianchi nati in America): se
quest’ultimi avevano in mano il potere economico (piantagioni
di caffè e cotone, miniere, commercio), erano invece i funzionari
provenienti direttamente da Madrid che gestivano l’amministrazione
pubblica, ben difendendo gli interessi fiscali e il regime di monopolio
della madrepatria; a questo conflitto strettamente economico, analogo
a quello determinatosi nelle colonie inglesi cinquant’anni prima,
che peraltro s’innestava in un clima di forte ribellione delle
popolazioni indigene sfruttate (celebre la rivolta peruviana del 1780
guidata da Tupac Amaru), si aggiunsero motivi di ordine
politico e ideale, anche grazie all’influenza degli intellettuali
che avevano come modelli la rivoluzione nordamericana e quella francese.
Ai primi dell’800 la popolazione delle colonie spagnole raggiungeva i 17 milioni, di cui la metà indios e poi meticci, neri, bianchi e creoli (bianchi nati in America): se
quest’ultimi avevano in mano il potere economico (piantagioni
di caffè e cotone, miniere, commercio), erano invece i funzionari
provenienti direttamente da Madrid che gestivano l’amministrazione
pubblica, ben difendendo gli interessi fiscali e il regime di monopolio
della madrepatria; a questo conflitto strettamente economico, analogo
a quello determinatosi nelle colonie inglesi cinquant’anni prima,
che peraltro s’innestava in un clima di forte ribellione delle
popolazioni indigene sfruttate (celebre la rivolta peruviana del 1780
guidata da Tupac Amaru), si aggiunsero motivi di ordine
politico e ideale, anche grazie all’influenza degli intellettuali
che avevano come modelli la rivoluzione nordamericana e quella francese. Durante l’invasione napoleonica del 1808 si ebbe la caduta della corona di Spagna, e questo ovviamente favorì molto le spinte indipendentistiche delle colonie, a partire dal Venezuela: nel luglio 1811 la Giunta municipale di Caracas guidata da Francisco Miranda proclamò l’indipendenza, dando il via a una guerra generalizzata; dopo una prima fase di insuccessi, il movimento guidato da José San Martìn in Argentina, Bernard O‘ Higgins in Cile e Simon Bolivar in Venezuela, riuscì a radicarsi diffusamente, a consolidarsi e a sconfiggere ripetutamente gli spagnoli; Bolivar arrivò addirittura a fondare gli Stati Uniti della Colombia, comprendenti anche Venezuela ed Ecuador, ma questo ambizioso progetto federativo ed altri analoghi (è del 1821 la proclamazione della Repubblica delle Province unite dell’America Centrale: Costarica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador) naufragarono poi sulla spinta degli interessi particolaristici delle borghesie locali. Fu proprio dai contrasti fra i vari gruppi delle borghesie nazionali che si aprì in quasi tutto il continente un lungo e confuso periodo di lotte intestine, a cui appunto lo stesso Garibaldi partecipò.
Un percorso differente seguì il Messico, dove le rivolte contadine di indios e meticci impaurirono molto la borghesia nazionale, che preferì in un primo tempo allearsi con la Spagna, salvo poi, nel 1822, proclamare l’indipendenza; il regime liberale proclamò l’abolizione della schiavitù e questo provocò la reazione dei grandi proprietari terrieri del nord del paese, che, appoggiati dagli Stati Uniti, diedero vita a un movimento secessionista: di qui la guerra fra i due paesi, conclusasi nel 1848 con l’annessione del Texas agli USA.
Avvenne invece pacificamente la separazione dalla madrepatria da parte del Brasile: andatovi in esilio dopo l’invasione francese, al suo ritorno in Portogallo il re lasciò sul posto come reggente il figlio don Pedro, che nel 1822 si fece proclamare imperatore, promulgando una Costituzione di impianto liberale che di fatto riuscì a prevenire un movimento rivoluzionario repubblicano.
In realtà il buon esito di questo processo indipendentistico a livello continentale ebbe fra le sue condizioni anche due importanti fattori internazionali: l’interesse dell’Inghilterra nel veder ridimensionata l’influenza di Spagna e Portogallo, prendendone il posto come leadership commerciale, e la cosiddetta dottrina Monroe, enunciata nel 1823 dal Presidente degli USA, secondo la quale le potenze europee non potevano più vantare diritti sulle Americhe, né tantomeno impegnarsi militarmente in quelle zone, lasciandole di fatto sotto l’influenza statunitense.
In Europa dopo le guerre napoleoniche vi fu un gravissimo calo della produzione alimentare e la diminuzione della capacità di consumo da parte delle famiglie provocò una forte contrazione del mercato interno, rendendo impossibile per le industrie (in particolare quella tessile) smaltire la propria produzione: ancora una volta, dunque, i fattori economici sono elemento decisivo nei sommovimenti politici, e in questo ambito ebbero notevole fortuna le iniziative cospirative delle Società segrete. La Carboneria, in particolare, riuscì a costruire una rete a livello europeo con lo scopo di avviare un movimento rivoluzionario che coinvolgesse contemporaneamente tutti i paesi, come condizione per impedire alla Santa Alleanza di concentrare la reazione su un singolo focolaio.
Questa strategia, peraltro assai acuta, negli anni ‘20 non ebbe successo, perché le forze della reazione erano ancora troppo forti. In Germania, dove pure la resistenza antinapoleonica aveva assunto un forte carattere liberale, la repressione di Metternich fu durissima e impedì qualsiasi cambiamento; e analogamente avvenne in Prussia.
In Francia le posizioni di timida apertura costituzionale di Luigi XVIII furono contrastate dagli ultrarealisti (di qui l’espressione più realisti del re), in maggioranza alla Camera, che scatenarono il terrore bianco e costrinsero il re a sciogliere il parlamento: l’opposizione liberale guidata da Benjamin Constant poté in qualche modo esprimersi alla luce del sole, ma il riacutizzarsi della lotta politica portò a una nuova svolta a destra e nel 1820 fu formato un governo che stroncò qualsiasi tentativo insurrezionale e seguì una politica assai vicina agli ultras.
Neppure l’Inghilterra, o meglio, il Regno Unito, dove il sistema costituzionale era consolidato, riuscì ad evitare un aspro scontro politico, che però si svolse a un livello più alto, focalizzandosi sull’esigenza di mutare il sistema elettorale, che premiava la rappresentanza politica dei centri rurali, e quindi dei grandi proprietari terrieri, a scapito di quella urbana, e cioè della borghesia imprenditoriale. Anima del riformismo inglese fu il filosofo John Bentham, la cui dottrina dell’utilitarismo diede una nuova base logica e morale ai principi illuministici, e il movimento poté svilupparsi tramite le numerose associazioni politiche e culturali da tempo formatesi nel paese; ma la classe dirigente inglese era ossessivamente antigiacobina e anche di fronte a rivendicazioni tutto sommato moderate non esitò ad avviare una vera e propria caccia alle streghe: nel 1818 fu soppresso l’habeas corpus ed emanati i Six Acts che vietavano ogni forma di associazione politica e sottoponevano la stampa a rigorosa censura.
In Spagna e in Italia la forte penetrazione delle società segrete nell’esercito riuscì, almeno temporaneamente, a produrre esiti diversi. Il venir meno delle entrate provenienti dalle colonie provocò un’aspra crisi economica, e l’impossibilità da parte del governo di pagare gli stipendi ai propri dipendenti fu il pretesto che portò (1820) alla sollevazione della guarnigione di Cadice e poi degli altri reparti: ciò costrinse il re a rimettere in vigore la Costituzione già promulgata nel 1812 e il governo ad approvare alcune misure contro i privilegi ecclesiastici e feudali.
In Italia, nel regno di Napoli, la rivoluzione del luglio 1820, guidata dal generale Guglielmo Pepe, vide la partecipazione di numerosi ufficiali aderenti alla Carboneria (e anche questo ne favorì molto il successo, diversamente da quanto era accaduto nel 1799) e costrinse il re Ferdinando I ad adottare una Costituzione simile a quella spagnola del 1812. Subito dopo scoppiò anche in Sicilia un’insurrezione, che però aveva una forte tendenza separatista, tesa cioè a staccare l’isola da Napoli, e questo costrinse il nuovo governo liberale napoletano a stroncare con la forza la rivolta.
Anche se la Carboneria italiana non aveva un programma comune a tutte le regioni italiane, certamente i fatti i Napoli contribuirono in modo decisivo a dar maggior vigore all’iniziativa liberale nell’Italia settentrionale, ma il governo austriaco riuscì a prevenire qualsiasi moto, arrestando i principali intellettuali raccolti intorno al Conciliatore: tra questi Piero Maroncelli e Silvio Pellico, che scontarono dieci anni di carcere nella fortezza dello Spielberg, dove appunto Pellico scrisse Le mie prigioni. La repressione non riuscì tuttavia a stroncare il movimento, che al contrario si rafforzò, e sotto la guida di Federico Confalonieri elaborò un programma che prevedeva l’unificazione del Lombardo-Veneto e del Piemonte in una monarchia sabauda di tipo costituzionale.
Anche Confalonieri venne arrestato, e il centro della lotta si spostò in Piemonte, dove nel marzo del 1821, ad Alessandria, si avviò un moto insurrezionale. In realtà nel regno di Sardegna la restaurazione seguita al crollo di Napoleone era stata addirittura più aspra che altrove e il re Vittorio Emanuele I si era fatto interprete delle istanze più retrive dell’aristocrazia; una certa apertura del principe ereditario, Carlo Alberto, verso le idee liberali, spinse sia i gruppi moderati di Santorre di Santarosa sia quelli radicali legati alla Carboneria, a tentare un accordo con lui, ma Carlo Alberto mantenne sempre un atteggiamento a dir poco ambiguo, oscillando tra le ipotesi di rinnovamento e la paura di non pregiudicare il proprio destino personale. Infatti, quando dopo l’insurrezione di Alessandria e di altre zone, Vittorio Emanuele abdicò a favore del fratello Carlo Felice e nominò reggente il figlio Carlo Alberto, costui dapprima cedette alle pressioni liberali concedendo lo Statuto, una Costituzione di tipo spagnolo, ma subito dopo, sconfessato dallo zio, di fatto si defilò dallo scontro: che nel frattempo si era esteso anche alla Lombardia, dove invano i patrioti attesero l’intervento armato piemontese (a questa speranza è dedicata l’ode manzoniana Marzo 1821), e che si concluse con l’intervento delle truppe austriache e di quelle piemontesi fedeli a Carlo Felice: nell’aprile, a Novara, gli insorti furono duramente sconfitti.
Nel frattempo il cancelliere Metternich organizzava vari congressi fra le grandi potenze per delineare un quadro di energici interventi controrivoluzionari; le riserve di Francia e Inghilterra a stabilire il principio in base al quale le potenze maggiori potessero intervenire militarmente dovunque venivano messi in pericolo i governi “legali”, non impedirono che di fatto venisse pianificato un intervento su larga scala per stroncare le rivoluzioni e i regimi liberali: il re Ferdinando I, malgrado gli impegni assunti col proprio governo, chiese l’aiuto dell’Austria, le cui truppe stroncarono la resistenza organizzata da Pepe ed entrarono a Napoli nel marzo 1821; analogamente, due anni dopo, un esercito francese intervenne in Spagna e abbatté il governo costituzionale.
In Russia i giovani ufficiali che avevano partecipato alla guerra del 1812 contro Napoleone avevano scoperto l'Europa e con essa l'arretratezza miserabile del proprio paese: di qui a trasformare lo sdegno in rivolta il passo fu assai breve; nacquero così le prime società segrete e l’ambizioso progetto di organizzare la sollevazione dell'esercito non appena, nell'estate del 1826, Alessandro I fosse stato ucciso dai congiurati di Pietroburgo; tutta una serie di imprevisti (dalla presenza di spie fra i cospiratori all'improvvisa dipartita, motu proprio, dello zar) mandò in fumo il piano, e così il complotto si risolse in un fallito pronunciamento di alcuni reggimenti della guardia, nel dicembre del 1825. Ma al programma dei decabristi (da dicembre) si sarebbe ispirata nei decenni successivi tutta l’intelligencija russa progressista.
In sostanza i moti del ‘20-21 furono sconfitti perché ebbero un carattere esclusivamente politico (le rivendicazioni costituzionali) e non riuscirono ad affrontare organicamente le questioni sociali ed economiche, in particolare aggregando quelle masse popolari che pure si stavano in parte allontanando dal tradizionale atteggiamento ostile nei confronti delle idee rivoluzionarie. In ogni caso queste esperienze ebbero il ruolo decisivo di dimostrare che i singoli regimi assolutistici erano piuttosto fragili, e che potevano reggersi solo grazie all’intervento delle altre potenze.
La rivoluzione ebbe un qualche successo solo in Grecia, dove però la situazione era del tutto particolare: il paese era sotto il dominio dell’impero ottomano, esteso dai Balcani all’Arabia, dall’Armenia alla Tripolitania, dove la minoranza turca governava mediante i governatori (pascià); questa situazione di potere era naturalmente malvista sia dalle potenze confinanti, Austria e Russia, tradizionalmente rivolte a espandersi rispettivamente verso i Balcani e verso il Mediterraneo, sia da Francia e Inghilterra, interessate al controllo militare del Mediterraneo e a quello commerciale dei mercati del Vicino Oriente; e in tale delicato e complesso gioco d’interessi questi paesi non potevano non vedere positivamente eventuali fattori di destabilizzazione del potere turco. Dalle prime azioni di patrioti greci a Costantinopoli la rivolta si diffuse nella Grecia propriamente detta e il 1° gennaio 1822 fu proclamata l’indipendenza: la tecnica del massacro (in uno di questi fu ucciso lo stesso patriarca ortodosso di Costantinopoli) divenne la caratteristica della spietata reazione turca, ma la resistenza greca fu eroica, suscitò una vastissima solidarietà e coinvolse numerosi occidentali (fra i tanti morirono Byron e Santorre di Santarosa); l’intervento della flotta anglo-franco-russa e poi la guerra aperta fra Turchia e Russia costrinse il sultano a cedere vari territori e a riconoscere (1827) l’indipendenza greca, che tuttavia si limitò solo a una parte del territorio ellenico e si realizzò attraverso una monarchia assoluta affidata a un principe di Baviera.
In ogni caso le potenze europee contraddicevano apertamente il principio da esse stesse stabilito, che cioè doveva essere mantenuto a tutti i costi lo status quo, e fu evidente che la politica e le relazioni fra stati non potevano più essere regolate unicamente dall’ideologia reazionaria.
IL 1830
Se il 1820 aveva rappresentato il primo segnale della non invincibilità dell’assolutismo, il 1830 fu la svolta decisiva nella lotta fra liberali e reazionari, perché in zone importanti dell’Europa (Francia, Belgio, Svizzera, Inghilterra, Spagna, Portogallo) si affermarono stabilmente regimi liberali e nell’area centro-orientale l’ancien régime vide restringersi notevolmente il proprio spazio di manovra, venendosi così a spezzare definitivamente il blocco reazionario costruito al Congresso di Vienna. Se in Austria, in Prussia, in Russia restavano sostanzialmente immutati i conflitti fra borghesia e residui di feudalesimo, nei paesi in cui si era affermata la svolta liberale lo scontro si spostava sulle nuove contraddizioni createsi con lo sviluppo del capitalismo, in particolare la lotta di classe tra il nascente proletariato e la borghesia agraria e industriale.
Il successore di Luigi XVIII alla corona di Francia, Carlo X, appoggiò con forza le posizioni degli ultras, restaurando vecchi privilegi feudali, indennizzando i nobili dei danni subiti nell’89, clericalizzando lo Stato; il suo primo ministro, Polignac, nel 1830 emanò quattro decreti che restringevano ulteriormente il diritto di voto, annullavano la libertà di stampa, scioglievano il parlamento ed indivano nuove elezioni: un vero e proprio tentativo di colpo di stato, che Carlo riteneva di portare a buon fine anche contando sull’entusiasmo popolare per la conquista dell’Algeria; ma questa impresa, che pure costituiva la base della nuova strategia coloniale francese in Africa, non produsse l’effetto desiderato, anche perché la crisi economica aveva causato un fortissimo malumore nelle masse popolari. Esse furono dirette protagoniste dell’insurrezione che alla fine di luglio per tre giornate (“les trois glorieuses”) sconvolse Parigi, ricordando molto da vicino il luglio dell’89; in effetti il movimento era diretto dai liberali, ostili sia al re che ai repubblicani, tant’è che lo sbocco della crisi fu l’incoronazione di Luigi Filippo d’Orléans, cugino del sovrano fuggito, definito “re dei Francesi”. L’immediato ripristino e l’ampliamento delle garanzie costituzionali diede il segno concreto che uno dei paesi più importanti d’Europa aveva imboccato con decisione la strada del cambiamento e ridiede forza e speranza ai gruppi democratici delle altre nazioni.
Il Belgio per primo seguì l’esempio francese e la rivoluzione, unendo l’obiettivo costituzionale a quello nazionale, portò all’indipendenza dall’Olanda; anche i cantoni della Svizzera adottarono costituzioni liberali.
In Inghilterra i whigs, sostenitori del Parlamento, insieme ai radicali, riaprirono la battaglia sul sistema elettorale, e pur con obiettivi diversi (i primi puntavano a una semplice ridistribuzione dei seggi, i secondi rivendicavano il diritto di voto anche per gli operai industriali ed agricoli), riuscirono a sconfiggere i tories e nel 1832 fecero approvare il Reform Act: la base elettorale fu estesa secondo lo schema proposto dai moderati, che presero ufficialmente il nome di liberali, e si andò profilando il sistema bipartitico, poi consolidatosi durante il regno di Vittoria (1837-1901). Il nuovo parlamento nel 1833 abolì la schiavitù nelle colonie, ma questo provvedimento impiegò oltre 50 anni per diventare patrimonio degli altri Stati: Francia 1848, Stati Uniti 1862-65, Olanda e Belgio 1863, Portogallo 1858-78, Brasile 1871-88.
In Spagna il fratello del re, Don Carlos, si mise alla testa degli ultras del suo paese, considerando troppo blande le pur non lievi misure repressive adottate dalla corona, e alla morte di Ferdinando scoppiò una guerra civile fra i carlisti e i liberali; analoga situazione in Portogallo, ma alla fine in entrambi i paesi prevalsero i rinnovatori, e anche nella penisola iberica si formarono regimi costituzionali, tali più di nome che di fatto, comunque, visto il permanere di profondissimi squilibri sociali e di pesanti residui feudali.
L’Italia, come altri paesi (ad esempio la Polonia), era in una situazione assai peggiore, perché subiva la doppia oppressione di regimi assolutistici e, direttamente o indirettamente, stranieri; d’altra parte la divisione della penisola non favorì certo l’iniziativa dei gruppi liberali, decimati o costretti all’esilio (in Francia si era costituita una Giunta di liberazione di cui faceva parte anche Filippo Buonarroti), e che oltre a tutto non erano riusciti a superare una certa visione municipalistica e ad elaborare un forte programma unitario; malgrado uno dei capi del movimento, Ciro Menotti, fosse stato arrestato, l’insurrezione coinvolse comunque la parte settentrionale dello Stato pontificio (febbraio 1821) e a Bologna si formò addirittura un governo provvisorio che dichiarò l’indipendenza da Roma: l’intervento austriaco fu immediato, la giunta rivoluzionaria venne spazzata via, Menotti fucilato, e l’ordine ripristinato.
 La sconfitta delle rivoluzioni del 1830-1, o il loro
sbocco in soluzioni decisamente moderate, provocò inevitabilmente
la rottura fra radicali e liberali: dove quest’ultimi avevano
preso il potere, si affrettarono a rompere coi vecchi alleati, considerandoli,
non a torto, il nuovo nemico; dove la lotta era stata comunque perduta,
La sconfitta delle rivoluzioni del 1830-1, o il loro
sbocco in soluzioni decisamente moderate, provocò inevitabilmente
la rottura fra radicali e liberali: dove quest’ultimi avevano
preso il potere, si affrettarono a rompere coi vecchi alleati, considerandoli,
non a torto, il nuovo nemico; dove la lotta era stata comunque perduta,
Dopo il 1830 andò comunque prendendo forma quel nuovo protagonista che già si era affacciato sulla scena politica con Babeuf, Saint-Simon e Fourier: un movimento socialista che tese ad organizzarsi autonomamente e a farsi espressione diretta dei braccianti agricoli e del sempre più numeroso proletariato urbano. E ciò non poteva che spingere la borghesia moderata su posizioni sempre meno liberali.
I radicali inglesi abbozzarono un manifesto politico (la Carta del popolo, da cui il movimento prese il nome di cartismo) con al centro il suffragio universale e su di esso raccolsero quasi un milione e mezzo di firme che presentarono ai Comuni: i deputati respinsero ogni richiesta e risposero con la repressione, che ancora per diversi anni riuscì a imbrigliare il movimento operaio. In Francia il maggior radicalismo delle correnti repubblicane favorì l'unità d’azione, o addirittura la fusione, coi gruppi socialisti, e le lotte operaie furono assai più estese, ma i tentativi di creare un movimento unitario e ben strutturato erano ancora deboli o viziati dalla tradizione cospirativa, come nel caso dell’organizzazione guidata da Auguste Blanqui. Fino al 1848, insomma, la classe operaia visse una stagione di “primitivismo politico”, come ebbe poi a scrivere Marx, ma anche di essenziale crescita, di passaggio da caotico arcipelago a movimento politico.
L'iniziale “intesa cordiale” fra i due nuovi grandi Stati costituzionali, Francia e Inghilterra, divenne ben presto concorrenza aperta nel campo internazionale, sia per determinare le rispettive zone d’influenza nel Vicino Oriente sia per gestire le alleanze a livello europeo; fermo restando che la politica estera degli Stati non avrebbe quasi mai più seguito ragioni di ordine ideologico, badando piuttosto agli specifici interessi economici o geopolitici, si può dire che la Francia preferì una linea di buon vicinato con gli Stati assolutistici, mentre l’Inghilterra, con l’abile regia del ministro degli esteri lord Palmerston, puntò decisamente a espandere l’impero, anche sfruttando l’aggressività commerciale che derivava dal proprio impetuoso sviluppo industriale.
La guerra dell’oppio (1840-2) fu l’episodio più significativo di questa strategia. Avendo la Cina deciso di chiudere le frontiere alla droga che i mercanti inglesi importavano dall’India, l’Inghilterra non esitò a reagire militarmente, imponendo la propria leadership commerciale in estremo Oriente e facendo di Hong Kong la base di una formidabile rete di scambi internazionali: la seta grezza cinese fu il perno di tale politica, e gli inglesi invasero il mercato europeo, dando una spinta fortissima all’industria tessile britannica e, fra l’altro, causando danni irreparabili alla sericoltura italiana.
Contestualmente prese forma anche il nuovo tipo di presenza inglese in India: completata la conquista del paese, alla Compagnia delle Indie venne tolto il monopolio del commercio, e fu creata una vera e propria amministrazione coloniale, con l’obiettivo di “anglicizzare” la regione. Il disegno britannico era però ancora di più largo respiro: l’Australia (utilizzata fino a poco tempo prima solo come luogo di deportazione) e la Nuova Zelanda erano territori dalle immense potenzialità e divennero un’utilissima valvola di sfogo per l’eccessivo incremento demografico; così pure l’Africa del Sud, dove la minoranza di coloni olandesi (i boeri) venne costretta a trasferirsi in altre zone. In Canada la minoranza di lingua francese era invece più radicata e ciò costrinse Londra a concedere al paese un’autonomia amministrativa piuttosto marcata.
Gli Stati Uniti d’America, ancora ben lontani dal rango di grande potenza, seguirono uno sviluppo del tutto particolare, caratterizzato dalle varie fasi e modalità dell’espansione verso Ovest: a pochi anni dall’indipendenza, nel 1787 il governo dettò le regole di tale espansione, fissando le norme in base alle quali i pionieri potevano entrare legalmente in possesso delle terre che conquistavano e stabilendo che le varie regioni dell’Ovest, una volta raggiunto un certo numero di abitanti, entrassero nell’Unione come Stati con pari dignità rispetto ai tredici originari. Il fatto che tali territori venissero in genere acquisiti dai pionieri in virtù della loro tenacia e non della loro disponibilità finanziaria, e perciò fossero considerati ciascuno con uguale dignità, e soprattutto che questi fossero di origine etnica, di fede, di culture diverse, diedero all’Unione un’impronta democratica di fondo, probabilmente unica rispetto a qualsiasi altra nazione. E, paradossalmente, il fatto che questo straordinario movimento di popolo sia avvenuto a scapito delle decine di migliaia di nativi massacrati senza pietà, non toglie nulla al fatto che gli Stati dell’Ovest si vennero formando sotto il segno di un’eguaglianza politica e di una libertà individuale non riscontrabili altrove. L’enorme sviluppo, quantitativo e tecnologico, che ebbero le comunicazioni (ferrovia, telegrafo, battelli a vapore) a metà del secolo fecero sì che questi elementi influenzassero direttamente anche la società del Nord-Est; perlomeno dal punto di vista strettamente politico, perché invece si accentuarono le differenziazioni in altri settori: nel Nord-Est erano concentrate le industrie e le grandi banche, mentre al Sud prevaleva il latifondo coltivato a cotone dagli schiavi.
Il contrasto sul problema della schiavitù non era tanto di ordine morale, quanto di tipo strettamente economico: l’organizzazione della fabbrica moderna rende sicuramente più conveniente per l’imprenditore pagare un salario ad operai che poi vivono autonomamente nei ghetti urbani, cioè acquistare la merce - lavoro per usarla un certo numero di ore al giorno e poi disinteressarsene; la coltivazione e la raccolta del cotone rendeva invece più conveniente per il grande proprietario terriero disporre a tempo pieno della forza lavoro e mantenerla con i frutti stessi della lavorazione della terra. Ma nella prima metà dell’800 questo contrasto non fu particolarmente acceso e furono decisamente pochi gli abolizionisti accesi (tra questi John Brown, in Kansas e in Virginia, che nel 1859 fu impiccato dagli schiavisti), e la questione venne regolamentata limitando la schiavitù ai
Il dissenso vero tra Nord e Sud riguardava i dazi che si pagavano alle frontiere dei vari Stati: gli industriali erano favorevoli al protezionismo doganale, mentre gli agrari, la cui fortuna era legata all’esportazione del cotone, erano per la totale libertà di scambio: questi ultimi organizzarono una scissione del partito repubblicano e nel 1854 fondarono il partito democratico; ecco, ancora una volta, che il conflitto d’interessi fra i vari gruppi economici è del tutto autonomo rispetto alle questioni etiche, tant’è che il presidente Jackson, pur essendo espressione delle esigenze convergenti degli agricoltori schiavisti e dei pionieri, entrambi soffocati dalla pressione delle banche del Nord-est, negli anni ‘30 diede un contributo decisivo all’estensione dei diritti politici alla grande maggioranza della popolazione (bianca). In questo insieme di contraddizioni sono da ricercare i motivi dello scoppio della guerra di secessione.
BORGHESIA E CLASSE OPERAIA
I moti europei del 1830 avevano evidenziato che da una parte il dominio straniero era l’ostacolo principale all’evoluzione in senso liberale e che dall’altra il blocco reazionario era fortemente indebolito: quindi l’elemento politico centrale dei movimenti di rivolta divenne il nazionalismo, accentuato anche dalla delusione per lo scarso spirito di solidarietà internazionale con cui i vari regimi liberali avevano appoggiato le lotte per la libertà nei paesi assolutistici; per questa ragione il nazionalismo in genere tese a svilupparsi più sul terreno del radicalismo che del liberalismo moderato, e coinvolgendo sempre più gli strati intellettuali.
Giuseppe Mazzini capì forse più d‘ogni altro quanto fosse decisivo il sentimento nazionalistico e infatti pose al centro del proprio programma l’obiettivo dell’unità nazionale, intesa come condizione essenziale per il progresso dell’Italia: il nuovo Stato unitario doveva nascere da una profonda rivoluzione politica e morale a forte impronta popolare, mentre altre strade, più moderate, non avrebbero che riproposto le vecchie soluzioni di compromesso, lasciando immutati i caratteri di fondo della società.
Nato a Genova nel 1805, Mazzini entrò nella Carboneria a poco più di vent’anni e nella sua produzione politico-letteraria ripropose le istanze più libertarie del romanticismo; arrestato una prima volta nel 1830 fu costretto all’esilio in Francia, dove entrò in contatto sia con gli ambienti vicini a Saint-Simon sia con Filippo Buonarroti, il quale riproponeva l’idea della repubblica unitaria già teorizzata durante l’epoca giacobina. Il dibattito politico verteva naturalmente sulle ragioni del fallimento dei moti del 1830, dovute in buona misura alla scarsa capacità delle forze democratiche di mobilitare le masse popolari, e ciò metteva in luce tutti i limiti della politica carbonara, settaria, ristretta a gruppi elitari, condizionata dal provincialismo. Nel 1831 Mazzini rivolse a Carlo Alberto, appena succeduto a Carlo Felice sul trono di Sardegna, un appello a farsi promotore di un grande movimento per l’Italia unita, e contemporaneamente fondò una nuova associazione, la Giovine Italia: il suo programma politico, fondato sugli obiettivi dell’unità e della repubblica, era improntato a un fortissimo sentimento di religiosità, non solo dal punto di vista strettamente cristiano, ma anche da quello della spinta morale, già tipica del romanticismo, che avrebbe dovuto spingere inevitabilmente gli uomini a lottare per il progresso: ne conseguiva - a differenza di quanto sostenevano coloro che vedevano nella Francia l’epicentro rivoluzionario - che l’Italia, con la sua straordinaria tradizione culturale, aveva una sorta di missione storica, in quanto il suo Risorgimento assumeva un valore universale di liberazione per tutta l’umanità.


La Giovine Italia raccolse immediatamente larghi consensi fra gli intellettuali e la media borghesia urbana, tanto da indurre i gruppi patriottici a promuovere vari, e del tutto prematuri, tentativi insurrezionali (1833-4) nel regno di Sardegna, in Toscana, a Palermo: la repressione fu immediata, molti furono gli arrestati e lo stesso Mazzini fu condannato a morte; la medesima sentenza fu pronunciata nei confronti di Giuseppe Garibaldi, che partecipò attivamente ai moti di Genova. Malgrado gli insuccessi, Mazzini intensificò l’azione politica e nel 1834 fondò a Berna un organismo che avrebbe dovuto estendere su scala continentale le idee democratiche, la Giovine Europa. I limiti del programma mazziniano sulla questione agraria furono tragicamente confermati (1844) dal tentativo di due suoi seguaci, i fratelli Bandiera, di organizzare una sollevazione popolare in Calabria: tutti i patrioti furono uccisi e questo ennesimo fallimento attirò numerose critiche su Mazzini, che si trovò anche a dover fare i conti con una forte ripresa del movimento liberale moderato.
La seconda grande tendenza del pensiero risorgimentale ebbe il suo rilancio con la pubblicazione di due importanti lavori politico-filosofici, il Primato morale e civile degli italiani, di Vincenzo Gioberti, e le Speranze d’Italia, di Cesare Balbo.
Pur rimanendo ancora molto arretrata rispetto allo sviluppo capitalistico ormai radicatosi profondamente in Inghilterra e in Francia, anche l’Italia risentì della rivoluzione europea delle comunicazioni, basata soprattutto sulla ferrovia, e avvertì il bisogno, per non essere tagliata fuori dai mercati europei, di rinnovare il sistema dei trasporti, riformare la politica dei dazi, modernizzare la produzione industriale e agricola, rendere più efficiente il sistema fiscale. Questo insieme di problemi era assolutamente alla base di qualsiasi ipotesi di rinnovamento, e se vennero in parte sottovalutati dalle correnti mazziniane, furono invece al centro delle riflessioni di quella borghesia non reazionaria refrattaria sia al generico umanitarismo dei romantici sia all’egualitarismo giacobino: proprio il giudizio negativo sulla rivoluzione francese era il collante di fondo dei moderati, che rimproveravano all’89 di aver interrotto traumaticamente l’opera dei sovrani illuminati e di negare il grande ruolo svolto dalla Chiesa cattolica; un forte spirito religioso, che però andava in direzione opposta a quanto auspicava Mazzini, era del resto alla base sia di opere letterarie come i Promessi Sposi, sia di contributi strettamente teorici come quelli di Antonio Rosmini, di Massimo D’Azeglio, e dei già ricordati Viesseux e Capponi; numerosi scienziati e uomini di cultura, inoltre, intervennero assiduamente ai dibattiti che sulle riviste e nei Congressi delle associazioni professionali si svolgevano sui problemi dell’istruzione, delle tecniche agrarie, dell’assistenza sociale.
Il Primato di Gioberti fu in qualche modo il manifesto programmatico di tutta questa importante corrente culturale cattolico-liberale, sottolineando la possibilità di realizzare drastici mutamenti politici senza traumi rivoluzionari: una sorta di binomio fra rinnovamento e conservazione che indicava nella confederazione fra gli Stati italiani lo sbocco politico fondamentale, ma che tuttavia non scioglieva i due nodi politici centrali, cioè la presenza egemone dell’Austria su tutta la penisola e il ruolo della Chiesa; ad essa Gioberti guardava come possibile guida del processo di riforma morale (e in questo senso tale posizione fu definita neoguelfismo), ma l’avversione profonda della Chiesa verso qualsiasi cambiamento (le ferrovie erano giudicate come opera di Satana!) rese molti liberali critici su questo punto, e indusse lo stesso Gioberti, dopo il 1848, ad abbandonare le precedenti posizioni e ad avvicinarsi notevolmente ai democratici. Nelle Speranze Cesare Balbo affrontò il problema dell’Austria dando un’interpretazione moderata all’idea mazziniana della solidarietà internazionale fra i popoli italiani, balcanici e slavi oppressi dall’Austria, e cioè affidando gli obiettivi indipendentistici soprattutto al gioco diplomatico fra le potenze; acutamente Balbo vide che lo smembramento dell’impero turco avrebbe spinto l’Austria ad espandersi verso Oriente, e in ciò vi era la forte possibilità che gli austriaci tendessero ad abbandonare progressivamente il Lombardo-Veneto: di qui la necessità di una riforma dei vari Stati italiani e di una loro alleanza che portasse, sotto la guida del re di Sardegna, allo sbocco unitario. D’Azeglio, disegnando le modifiche economiche e istituzionali necessarie, precisò la strategia moderata basata sulla pressione dell’opinione pubblica per modificare le Costituzioni dei vari Stati italiani, ridimensionando ulteriormente l’originaria matrice religiosa del movimento liberale e dandogli sempre più un’impronta laica.
All’interno dello schieramento moderato ebbe poi una funzione assai significativa una corrente di pensiero che prendeva le mosse dalle acute analisi che il milanese Gian Domenico Romagnosi aveva svolto sui problemi dello sviluppo capitalistico italiano (libertà completa dei commerci, ammodernamento degli impianti industriali e delle infrastrutture, riforma delle strutture amministrative): dal 1839 al 1844 Carlo Cattaneo riprese organicamente questi temi di analisi sulla sua rivista Politecnico, rendendola uno degli strumenti culturali più vivaci e moderni di tutto il Risorgimento e facendone il punto di riferimento di quel federalismo democratico e repubblicano che vedeva nell’Italia dei Comuni il momento più importante della storia italiana, l’esempio da seguire per cambiare davvero il paese.
Dove si era affermato il regime liberale, seppur in modo differenziato nei vari paesi europei, era stato drasticamente ridimensionato il monopolio ecclesiastico o feudale sulla terra, e questa ridistribuzione fondiaria (che nel contempo eliminò anche antichi usi in base ai quali i contadini poveri potevano coltivare in comune certi appezzamenti) permise a un nuovo strato di borghesia imprenditoriale di utilizzare l’importantissima risorsa costituita dalla terra, investendo consistenti capitali, innovando le tecniche di produzione (che alla fine del secolo fecero un enorme balzo in vanti con l’inizio della meccanizzazione e dell’introduzione dei fertilizzanti chimici), eliminando vecchi rapporti di lavoro e di gestione ed introducendo anche nelle campagne il sistema del lavoro salariato. Gli enclosures acts emanati in Inghilterra nel 1845, che avevano liquidato sia i privilegi feudali sia i diritti di pascolo e di semina dei contadini, beneficiarono i grandi proprietari terrieri e diedero il via alla diffusione massiccia dell’azienda agraria capitalistica; al tempo stesso moltissimi contadini furono privati di ogni rapporto (sotto forma di piccola proprietà o di contratti colonici o di diritti acquisiti) con la terra e dovettero abbandonare la campagna, andando a ingrossare l’esercito di manodopera indispensabile per le fabbriche. Laddove si realizzò, questo sviluppo del capitalismo nelle campagne è in qualche modo la diretta conseguenza della rivoluzione industriale ed è il passaggio decisivo dei grandi mutamenti socioeconomici di metà ‘800.
A quello inglese si contrappose il modello prussiano di sviluppo capitalistico, perché non i borghesi ma gli stessi ex feudatari (Junker) divennero i grandi proprietari, garantendo quindi all’aristocrazia il mantenimento del predominio sociale ed economico. Ancora diverso il caso della Francia, dove la partecipazione contadina alla rivoluzione dell’89 consentì che a fianco della grande azienda capitalistica permanessero in modo diffuso piccole e medie proprietà. In Spagna e in Italia meridionale queste trasformazioni furono ridottissime, e la proprietà terriera rimase in mano ai vecchi latifondisti, disinteressati all’innovazione; e così pure in Irlanda, dove, con qualche decennio di anticipo rispetto all’Italia, si avviò un massiccio flusso migratorio verso il nord America.
Se dunque l’economia europea restava prevalentemente di tipo agricolo, la rivoluzione industriale aveva ormai gettato in modo irreversibile le basi per lo sviluppo della grande fabbrica, e si andava ormai profilando un vero e proprio sistema industriale, caratterizzato dalla possibilità per le aziende di attingere alla forza lavoro concentratasi nelle grandi città, dalla modernizzazione e capillarità della rete bancaria, dai rapporti sempre più stretti fra industria e agricoltura per la produzione alimentare, dalla facilità dei trasporti, dall’aumento dei prodotti coloniali da sottoporre a trasformazione o lavorazione. Comunque il fattore propulsivo fondamentale del capitalismo e della sua capacità di superare le crisi politiche ed economiche che di volta in volta si presentarono, fu la stessa integrazione fra i settori industriali: più seta e cotone arrivavano dalle colonie, più cresceva la domanda di abbigliamento, e più fabbriche tessili sorgevano più aumentava la richiesta di macchine tessili; e più prodotti venivano commercializzati più era essenziale sviluppare le ferrovie: questi ed altri sistemi di interazione portarono rapidamente l’industria metalmeccanica e siderurgica, che producevano telai, locomotive, macchine, rotaie, ecc., ad essere la punta avanzata di tutto il sistema.
Naturalmente i paesi che possedevano le materie prime (carbone e ferro) si trovarono avvantaggiati rispetto agli altri, ma occorrevano anche altri fattori per far parte integrante del mercato industriale: capitali, manodopera, leggi moderne, inventiva, e i paesi che non furono in grado di competere su tutti questi fronti si trovarono ad essere sempre più distanziati dagli altri, restando sottosviluppati: a questo divario, che Marx chiamò “sviluppo ineguale del capitalismo”, sono riconducibili molti dei conflitti e degli squilibri che segnarono la storia mondiale in quel secolo.
Un’altra caratteristica di fondo del nuovo sistema capitalistico era il superamento del sistema di gestione aziendale basato sulla capacità di autofinanziamento del proprietario e sulla proprietà familiare: aumentando vertiginosamente la necessità di far fronte a nuovi e consistenti investimenti, la possibilità di accedere con rapidità ai capitali necessari divenne essenziale, e di qui il ruolo primario assunto dal capitale finanziario, cioè dalle banche, che garantivano il credito necessario, facevano fruttare il denaro dei risparmiatori investendolo nelle attività industriali di maggior successo, e spesso diventavano esse stesse promotrici o proprietarie di tali attività; le nuove leggi sulle società per azioni consentirono poi da una parte di distribuire i propri investimenti con maggior efficacia e minor rischio (perché in caso di fallimento l’azionista rispondeva solo per l’importo delle azioni possedute), e dall’altra di impegnarsi in sfide economiche particolarmente impegnative acquisendo nuovi soci nella propria attività.
La borghesia capitalistica era dunque rapidamente diventata la classe trainante dal punto di vista dello sviluppo, e così come aveva rovesciato a proprio favore i rapporti economici fino a poco tempo prima gestiti dalla nobiltà, analogamente tendeva a fare sul piano del ruolo sociale e politico: da un lato rivendicando per sé l’autorevolezza e il peso che le derivavano dai traguardi raggiunti non per virtù divina o di sangue ma attraverso il lavoro e il rischio, dall’altro puntando a gestire direttamente il potere: ma veniva rifiutato qualsiasi tentativo d’ingerenza nell’economia da parte dello Stato, che doveva rigorosamente limitarsi a garantire la condizione primaria dello sviluppo, cioè il libero dispiegarsi dell’iniziativa privata, rimuovendo tutti gli ostacoli che ad essa potevano frapporsi. E tra questi, naturalmente, vi era il tentativo della classe lavoratrice di migliorare la propria condizione.
I contadini sradicati dalle campagne che erano andati a formare il nuovo strato sociale del proletariato urbano, non avevano altro mezzo di sussistenza che vendere l’unica cosa che possedevano, la propria forza-lavoro, nell’ambito di un sistema basato su un'attività dequalificata e ripetitiva, e sulla ferrea disciplina; a queste dure condizioni si sommava il più delle volte l’impossibilità di contrattare il salario, perché la grande massa di disoccupati consentiva al padrone di scegliere fra coloro (anche bambini) che si offrivano per la paga più bassa e per l’orario di lavoro più lungo. Ma non era solo il sistema della fabbrica in sé ad essere disumano, perché la vita stessa degli operai avveniva in situazioni intollerabili: abitazioni fatiscenti, sottoalimentazione, analfabetismo, elevata mortalità. Sia nella saggistica (Friedrich Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra, 1845) che nella letteratura (Balzac, Dickens) cominciò ad essere denunciato questo terribile stato di cose, ma la violenta opposizione della borghesia e dei suoi rappresentanti politici impediva qualsiasi mutamento. Solo nel 1844, in Inghilterra, venne approvata una legge che portava a 12 ore e poi a 10 il limite massimo di ore per le donne e i fanciulli, anche se l’applicazione di questa norma rimase in buona misura disattesa.
A fronte di queste condizioni di lavoro e di vita, fra gli operai in qualche misura si creò spontaneamente un senso di solidarietà, ma i primi tentativi di organizzazione e di rivolta si realizzarono in modi ingenui e limitati; così scriverà uno dei grandi teorici del movimento operaio, Karl Kautsky, ripreso poi da Lenin in una delle sue opere più celebri, Che fare?: “La coscienza socialista contemporanea non può sorgere che sulla base di profonde cognizioni scientifiche. Il detentore della scienza non è il proletariato, ma sono gli intellettuali borghesi; anche il socialismo contemporaneo è nato nel cervello di alcuni membri di questo ceto, ed è stato da essi comunicato ai proletari più elevati per il loro sviluppo intellettuale, i quali in seguito lo introducono nella lotta di classe del proletariato, dove le condizioni lo permettono. La coscienza socialista è quindi un elemento importato nella lotta di classe del proletariato dall’esterno e non qualche cosa che sorge spontaneamente.” Furono appunto i generosi tentativi dei primi teorici del socialismo utopistico a creare le premesse affinché i lavoratori stessi praticassero forme organizzative e di lotta basate su una valutazione concreta della realtà e su una strategia politica di medio periodo.
Le prime associazioni di mestiere, cioè di categoria, furono le Trade unions inglesi, da cui poi partì il tentativo di costruire sia sindacati nazionali di categoria sia organismi generali di coordinamento fra i vari settori: e si deve appunto a questi nuclei e al movimento cartista la conquista del Ten hours Bill, la legge che limitava a 10 ore la giornata lavorativa degli adulti.
In Francia il movimento ebbe un carattere più marcatamente politico, ma proprio per questo si sviluppò in forme cospirative che non potevano necessariamente avere contatti di massa con gli ambienti operai: rifacendosi al comunismo babuvista, senza tuttavia superarne i limiti propri delle società segrete, Auguste Blanqui (da non confondersi con Louis Blanc, che proprio negli stessi anni proponeva le idee socialiste in una chiave decisamente più moderata) svolse un’intensa attività organizzativa e di elaborazione politica, sfociata nella disastrosa e minoritaria insurrezione del 1839; affiliata all’organizzazione di Blanqui, la Società delle stagioni, era un’altra associazione rivoluzionaria formata da profughi tedeschi a Parigi, la Lega dei giusti, che, dopo aver partecipato all’insurrezione fallita, si trasferì a Londra, dove riorganizzò le proprie file e prese il nome di Lega dei comunisti: essendo riuscita a creare propri nuclei organizzati in varie città d’Europa, la Lega divenne una robusta organizzazione internazionale e nel 1848 si diede una vera e propria struttura di partito. A redigerne il programma furono chiamati Friedrich Engels e Karl Marx, e il Manifesto del partito comunista divenne uno dei più celebri documenti politici della storia, oltre che uno dei più riusciti esempi di divulgazione.
IL
1848
 In realtà le forze reazionarie vedevano in ogni protesta e rivendicazione,
anche le più limitate, lo spettro della sovversione comunista,
senza cogliere invece la complessità di fenomeni che variavano
molto da paese a paese, e che andavano da semplici richieste sindacali
sul salario e sull’orario a istanze di indipendenza nazionale,
da moderati disegni di riforma costituzionale a veri e propri progetti
rivoluzionari di stampo socialista. Il fatto che le stesse agitazioni
operaie sovente avessero il carattere di rifiuto dell’industrializzazione
(addirittura ricordando le agitazioni luddiste), sta a indicare che
i fermenti di rivolta erano diretti, più che verso la borghesia,
contro il vecchio ordine feudale o i suoi residui ancora ben presenti
anche nelle società liberali. Negli Stati tedeschi, in Polonia,
in Italia, in Austria, prevaleva naturalmente la rivendicazione nazionale,
altrove l’esigenza di dare concreta attuazione ai principi affermati
nelle costituzioni.
In realtà le forze reazionarie vedevano in ogni protesta e rivendicazione,
anche le più limitate, lo spettro della sovversione comunista,
senza cogliere invece la complessità di fenomeni che variavano
molto da paese a paese, e che andavano da semplici richieste sindacali
sul salario e sull’orario a istanze di indipendenza nazionale,
da moderati disegni di riforma costituzionale a veri e propri progetti
rivoluzionari di stampo socialista. Il fatto che le stesse agitazioni
operaie sovente avessero il carattere di rifiuto dell’industrializzazione
(addirittura ricordando le agitazioni luddiste), sta a indicare che
i fermenti di rivolta erano diretti, più che verso la borghesia,
contro il vecchio ordine feudale o i suoi residui ancora ben presenti
anche nelle società liberali. Negli Stati tedeschi, in Polonia,
in Italia, in Austria, prevaleva naturalmente la rivendicazione nazionale,
altrove l’esigenza di dare concreta attuazione ai principi affermati
nelle costituzioni.Al di là di queste sostanziali differenze, vi fu un elemento comune a tutte le rivoluzioni del ‘48, e cioè il ruolo finalmente di primo piano svolto dalle correnti democratiche, che ovunque presero l’iniziativa, sovente riuscendo ad avere un ruolo egemone.
La crisi economica che attraversò l’Europa fra il 1845 e il 1847, dovuta in buona misura ai cattivi raccolti, creò un profondo malcontento sia tra i lavoratori che tra le classi medie, e per certi aspetti anche fra la borghesia industriale: è questa la premessa della rivoluzione del 1848, da cui, significativamente, rimasero immuni i due poli opposti dello sviluppo, l’Inghilterra liberale e industrializzata e il paese più arretrato, la Russia: qui non diminuirono le disperate rivolte contadine, che però non riuscirono a trovare una loro unità e uno sbocco politico, mentre l’opposizione all’autocrazia zarista rimase ristretta all’intelligencija liberale, a sua volta incapace di creare un collegamento col popolo: e da questo punto di vista non furono certo sufficienti grandi esperienze di letteratura “impegnata”, ad opera di Lermontov, Puskin, e soprattutto di Gogol (Le anime morte, 1842).
La scintilla della rivoluzione scoppiò in Italia: nel 1846 era stato eletto un pontefice, Pio IX, che manifestò delle caute aperture riformistiche, divenendo subito un punto di riferimento, altamente simbolico, per tutte le forze liberali e democratiche; la pubblicazione della Proposta di un programma per l’opinione nazionale italiana, di Massimo D’Azeglio, ridiede slancio all’opinione pubblica liberale, che fece del libro il proprio manifesto politico, ma fu l’introduzione da parte del papa della libertà di stampa nello Stato pontificio a dare una diffusa sensazione che fossero ormai maturi i tempi del grande cambiamento. Sotto l’influenza di questo clima, anche in altri Stati, come la Toscana, i sovrani fecero varie concessioni politiche, e lo stesso Carlo Alberto permise la libertà di stampa. Alla grande attesa non corrisposero però iniziative costituzionali concrete, e di fronte alle titubanze dei moderati i democratici presero decisamente l’iniziativa: vi furono numerose manifestazioni antiaustriache a Genova, a Venezia, in Lombardia, in Toscana, a Napoli, ma fu l’anello debole della catena reazionaria a spezzarsi, con l’insurrezione di Palermo del gennaio 1848, guidata da Rosolino Pilo; il successo conseguito con la formazione di un governo provvisorio fece sì che la rivolta si estendesse in tutto il Mezzogiorno, costringendo il re Ferdinando II a concedere la Costituzione. Sotto la forte spinta dell’opinione pubblica, e per prevenire rotture rivoluzionarie, anche Carlo Alberto e il granduca di Toscana concessero la carta costituzionale.
Nel frattempo la piccola borghesia francese e i lavoratori erano diventati sempre più insofferenti verso lo strapotere della grande borghesia, che tuttavia in parlamento era all’opposizione rispetto alle forze più reazionarie: questo paradosso pose in primo piano l’esigenza della riforma elettorale, che divenne l’obiettivo prioritario dei repubblicani e dei socialisti moderati di Louis Blanc: il governo reagì con miope intransigenza e inviò contro una manifestazione popolare la Guardia nazionale, che però si schierò dalla parte degli insorti; Luigi Filippo cercò di ricorrere ai ripari sostituendo il primo ministro, ma ormai la rivoluzione era dilagata, e il 24 febbraio 1848 Parigi era in mano degli insorti guidati da repubblicani e socialisti. Il governo provvisorio diretto da Alphonse Lamartine proclamò la repubblica, introdusse il suffragio universale maschile, abolì la pena di morte e la schiavitù, portò la giornata lavorativa a 10 ore; altrettanto importante fu il solenne impegno del governo a garantire il diritto al lavoro, che si tradusse immediatamente nella creazione di officine statali (ateliers nationaux) per arginare la disoccupazione: sembrava davvero che dopo la delusione del 1830 i lavoratori avessero potuto influenzare sostanzialmente le scelte politiche, ma la Commissione governativa composta anche dai rappresentanti sindacali si rivelò ben presto inefficace, e i vari provvedimenti per il lavoro furono ritirati o resi ininfluenti; la destra aprì una furibonda campagna antisocialista e alle elezioni di aprile la maggioranza fu conquistata dai moderati. La “repubblica del lavoro” era finita prima di cominciare, ma di fronte all’ulteriore ridimensionamento dei provvedimenti sociali nel giugno il proletariato parigino insorse nuovamente: era l’occasione che molti aspettavano per la resa dei conti finale col “pericolo rosso” e l’esercito stroncò la rivolta facendo migliaia di morti; la fucilazione senza processo, dopo la fine degli scontri, di oltre tremila insorti, segnò che la reazione aveva vinto in maniera schiacciante.
 Nel marzo era frattanto insorta anche Vienna, e Metternich
dovette fuggire: fu il segnale per le nazionalità oppresse dall’Austria,
e sia a Budapest, sotto la guida di Lajos Kossuth,
che a Praga si costituirono governi costituzionali che diedero avvio
a varie riforme. La pressione popolare e l’insurrezione di Berlino costrinsero anche il re di Prussia Guglielmo IV a convocare un’assemblea
costituente, che emanò subito tutta una serie di provvedimenti
liberali (dalla libertà di stampa al suffragio universale maschile);
negli altri Stati tedeschi e nella stessa Prussia la rivoluzione non
affrontò solo la questione costituzionale ma pose con forza anche
il problema dell’unità nazionale, e venne convocata un‘assemblea
di tutte le popolazioni tedesche, il Parlamento di Francoforte, per
elaborare un progetto di nuovo Stato unitario. Ma ciò che sarebbe
divenuto realtà appena pochi anni dopo (1871), sembrò
allora troppo azzardato e il re di Prussia non accolse con favore l’idea,
e anzi l’anno successivo sciolse con la forza tale organismo.
Nel marzo era frattanto insorta anche Vienna, e Metternich
dovette fuggire: fu il segnale per le nazionalità oppresse dall’Austria,
e sia a Budapest, sotto la guida di Lajos Kossuth,
che a Praga si costituirono governi costituzionali che diedero avvio
a varie riforme. La pressione popolare e l’insurrezione di Berlino costrinsero anche il re di Prussia Guglielmo IV a convocare un’assemblea
costituente, che emanò subito tutta una serie di provvedimenti
liberali (dalla libertà di stampa al suffragio universale maschile);
negli altri Stati tedeschi e nella stessa Prussia la rivoluzione non
affrontò solo la questione costituzionale ma pose con forza anche
il problema dell’unità nazionale, e venne convocata un‘assemblea
di tutte le popolazioni tedesche, il Parlamento di Francoforte, per
elaborare un progetto di nuovo Stato unitario. Ma ciò che sarebbe
divenuto realtà appena pochi anni dopo (1871), sembrò
allora troppo azzardato e il re di Prussia non accolse con favore l’idea,
e anzi l’anno successivo sciolse con la forza tale organismo.La caduta di Metternich fu il segnale per i patrioti italiani e nel marzo 1848 insorsero Venezia, dove fu restaurata la Repubblica veneta, sotto la guida di Daniele Manin, e Milano, dove si costituì un consiglio di guerra presieduto da Carlo Cattaneo che per cinque giornate fronteggiò le truppe austriache del generale Radetzky, poi costrette a rifugiarsi nelle fortezze del cosiddetto quadrilatero (Mantova, Peschiera, Verona e Legnago). Mentre anche a Parma e a Lucca i sovrani furono cacciati, i liberali milanesi, preoccupati che l’insurrezione assumesse una marcata tendenza democratica, rivolsero insistenti appelli a Carlo Alberto affinché intervenisse militarmente, e il re di Sardegna, anche riesumando le vecchie aspirazioni sabaude sulla Lombardia, dichiarò guerra all’Austria.
La cosiddetta prima guerra d’indipendenza creò un fortissimo clima unitario fra le varie componenti patriottiche: Mazzini, giunto prontamente a Milano, rinunciò a qualsiasi rivendicazione repubblicana, e Cattaneo sostenne la necessità di rinviare qualsiasi discussione sul futuro assetto dei territori italiani e di concentrare ogni sforzo nella guerra; oltre ai volontari che accorrevano da tutta Italia, la pressione popolare costrinse vari Stati (Roma, Toscana, Napoli) a inviare contingenti di truppe, che, come nel caso di Guglielmo Pepe, furono messe al comando di generali liberali.
L’incertezza politico-militare dei Piemontesi, che ad esempio rifiutarono l’offerta di Garibaldi di partecipare direttamente alla guerra, consentì a Radetzky di far ritirare le proprie truppe senza perdite e di preparare la controffensiva; anche se i vari governi provvisori si pronunciarono per la fusione col Piemonte, la svolta decisiva si ebbe quando il papa chiuse la parentesi “neoguelfa” e ritirò le proprie truppe, subito imitato dal Granduca di Toscana e dal re di Napoli, che nel frattempo aveva messo in atto un colpo di stato: a Goito gli italiani vinsero una battaglia, conquistando la fortezza di Peschiera, e a Curtatone e Montanara i volontari toscani conseguirono un importante successo, ma Radetzky ottenne a Custoza la vittoria decisiva, obbligando Carlo Alberto a firmare (9 agosto) l’armistizio. Così Antonio Gramsci spiegò le cause della disfatta: “La politica incerta, ambigua, timida e nello stesso tempo avventata dei partiti di destra piemontesi fu la ragione principale della sconfitta; essi furono di un’astuzia meschina, furono la causa del ritirarsi degli eserciti degli altri Stati italiani, per aver troppo presto mostrato di volere l’espansionismo piemontese e non una confederazione italiana; essi non favorirono, ma osteggiarono il movimento dei volontari; essi, insomma, volevano che armati e vittoriosi fossero solo i generali piemontesi, inetti al comando di una guerra tanto difficile.”
La rivoluzione parigina era stata stroncata appena un mese prima ed era stato il segnale generale del riflusso rivoluzionario e della rivincita reazionaria. Alle elezioni di dicembre prevalse il candidato conservatore Luigi Bonaparte, nipote di Napoleone, che presto avrebbe seguito le abitudini di famiglia, scegliendo la strada del potere personale.
L’esercito austriaco bombardò Praga in giugno e dopo marciò su Vienna, assediando la città e riconquistandola dopo alcune settimane; il nuovo imperatore Francesco Giuseppe, incoronato dopo l’abdicazione di Ferdinando, ripreso il controllo della capitale puntò subito a ripristinare l’ordine in Ungheria: per quasi un anno i patrioti ungheresi, sempre sotto la guida di Kossuth, riuscirono a resistere, finché l’intervento dell’esercito russo fece capitolare la città.
Dopo il colpo di stato a Napoli, la rivoluzione si esauriva in tutta l’Italia meridionale, mentre a Roma i patrioti rilanciarono l’iniziativa, tanto che Pio IX dovette rifugiarsi a Gaeta; nel febbraio del 1849 fu eletta un’Assemblea costituente che proclamò la fine del potere temporale del papa e la nascita della Repubblica romana, alla cui guida fu chiamato un triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. L’ipotesi di un’unione con la Toscana, il cui governo democratico era presieduto da Francesco Guerrazzi, incontrò le forti resistenze dei moderati, finché nel luglio anche in Toscana la reazione riuscì a prevalere e il granduca tornò sul trono.

Solo Roma e Venezia continuarono la rivoluzione, ma già un corpo di spedizione francese era pronto a intervenire, perché il presidente Luigi Bonaparte voleva conquistarsi l’appoggio dei clericali e liquidare definitivamente l’opposizione radicale; mentre Garibaldi combatteva più a sud contro i borbonici, battendoli ripetutamente, i francesi assediavano Roma, che pure resisteva con fortissima tenacia, e solo nel mese di luglio i capi militari, Garibaldi e Carlo Pisacane, decisero che era impossibile continuare oltre: l’Assemblea costituente decise di promulgare, prima di sciogliersi, la Costituzione che prevedeva il suffragio universale. L’importanza della Repubblica romana non fu solo simbolica, per l’eroismo con cui aveva combattuto, ma soprattutto per gli atti concreti di riforma che aveva avviato, primo fra tutti il riordino fondiario tramite l’espropriazione dei beni ecclesiastici e la concessione delle terre ai contadini, la prima vera e propria riforma agraria mai tentata in Italia, cioè la base di quella rivoluzione rimasta sempre incompiuta nel nostro paese.
Dopo il crollo dell’Ungheria si capì che anche per Venezia il destino era segnato, e, malgrado molti patrioti fossero accorsi da altre regioni, la Repubblica dovette cedere alle truppe nemiche, alla fame e al colera, arrendendosi alla fine di agosto.
Nel regno di Sardegna si era nel frattempo decisa la ripresa delle ostilità verso l’Austria, e, visti gli scarsi risultati ottenuti dai generali piemontesi, il comando delle truppe fu affidato a un generale polacco: che però non ebbe maggior successo, perché gli austriaci vinsero rapidamente e in modo decisivo a Novara (marzo ‘49); il nuovo re Vittorio Emanuele II (Carlo Alberto aveva appena abdicato) firmò un armistizio piuttosto favorevole, dato che non comportava perdite territoriali o la revoca dello Statuto albertino. Durante la guerra era insorta Brescia, e il patriota Tito Speri guidò una disperata resistenza che durò dieci giorni, al termine dei quali l’Austria aveva ripristinato l’ordine in tutto il nord Italia.
L’UNITÀ D’ITALIA
La Chiesa cattolica era fortemente preoccupata da questa svolta liberale, seppur moderata, e, dopo aver constatato l’impossibilità di rispondere al ‘48 con una restaurazione analoga a quella del ‘15, s’impegnò a dar battaglia sul piano politico: il conflitto fra Stato liberale e Chiesa divenne aperto prima con il Sillabo papale del 1864, attraverso il quale il Vaticano dichiarò l’inconciliabilità della dottrina cristiana col progresso e col liberalismo, e poi con un rinnovato rigore dottrinario che portò alla proclamazione (1870) del dogma dell’infallibilità del papa. Al grande periodo rivoluzionario seguì dunque una fase in cui la vita politica europea fu dominata dalle diplomazie internazionali e dai suoi protagonisti: Bismarck, Palmerston, Napoleone III, Cavour; contemporaneamente si andarono rafforzando le spinte nazionalistiche nei paesi slavi e balcanici, crollò definitivamente l’impero turco, aumentò fortemente l’influenza occidentale in India, Giappone e Cina, e gli Stati Uniti furono protagonisti di uno straordinario sviluppo economico. Questo processo di crescita capitalistica investì tutti i paesi, soprattutto per l’effetto del liberismo economico che ridusse fortemente le barriere doganali; non a caso la rete ferroviaria europea quintuplicò la propria estensione nel giro di vent’anni.
All’inizio di questa fase storica in Francia rinacque addirittura l’impero; la disfatta della rivoluzione del febbraio 1848 non significò solo il fallimento delle aspirazioni popolari, ma aprì la strada a uno sbocco decisamente autoritario: approfittando dei contrasti fra moderati e repubblicani, il presidente Luigi Bonaparte attuò un colpo di stato nel dicembre 1851, sciogliendo il parlamento e preparando il terreno costituzionale che gli permise, l’anno dopo, di farsi proclamare imperatore col nome di Napoleone III. Dall’iniziale autoritarismo Napoleone passò a una graduale attenzione verso le istanze della borghesia liberale, concedendo maggiori poteri al parlamento e arrivando persino a riconoscere il diritto degli operai ad associarsi per scopi sindacali; questa apertura consentì da una parte la rinascita di un’opposizione repubblicana, dall’altra una sintonia crescente con la borghesia capitalistica, che si rese protagonista di alcune grandi iniziative: la costruzione del canale di Suez (1859-69) e la modernizzazione di Parigi, che diede alla città i suoi grandi boulevards. Quando si parla di secondo impero non ci si riferisce solo al fatto cronologico, ma anche al tentativo di Napoleone III di ripercorrere in qualche modo la strada seguita dal predecessore, rompendo gli equilibri scaturiti dal Congresso di Vienna e ridando alla Francia quella supremazia di cui era stata privata dalle altre potenze. Questo disegno fu in parte agevolato dalle tensioni fra Austria e Prussia, in concorrenza per l’egemonia sulla regione di lingua tedesca, e dalla comparsa sulla scena politica internazionale di un nuovo protagonista, il piccolo regno di Sardegna che sarebbe diventato regno d‘Italia.
 La prima guerra d’indipendenza italiana si risolse in un rafforzamento
dell’Austria, che in pratica controllava, direttamente o indirettamente
tutta l’Italia, fatta eccezione per il regno delle Due Sicilie
e quello di Sardegna. Il primo aveva visto una ripresa integrale dell’assolutismo,
che bloccò qualsiasi progresso politico, economico e sociale,
e in questo immobilismo si rivelò la fragilità del regime,
tanto che la “questione napoletana”
attirò l’attenzione dei molti che ipotizzavano di riuscire
a riprendere il cammino unitario, magari proprio a partire da questo
anello debole della catena.
La prima guerra d’indipendenza italiana si risolse in un rafforzamento
dell’Austria, che in pratica controllava, direttamente o indirettamente
tutta l’Italia, fatta eccezione per il regno delle Due Sicilie
e quello di Sardegna. Il primo aveva visto una ripresa integrale dell’assolutismo,
che bloccò qualsiasi progresso politico, economico e sociale,
e in questo immobilismo si rivelò la fragilità del regime,
tanto che la “questione napoletana”
attirò l’attenzione dei molti che ipotizzavano di riuscire
a riprendere il cammino unitario, magari proprio a partire da questo
anello debole della catena.Il Piemonte aveva conservato il suo ordinamento costituzionale, anche se non esitò a reprimere con forza l’insurrezione di Genova del ‘49; il fatto che alla Camera ci fosse una preoccupante maggioranza liberal-progressista indusse il re a indire nuove elezioni, proclamando che lo Statuto si poteva salvare solo ridimensionando le forze antimonarchiche: i risultati elettorali lo premiarono, e il primo ministro Massimo D’Azeglio diede il segno di voler effettivamente riprendere, pur con la dovuta cautela, la strada delle riforme; nel 1850 furono approvate varie leggi che limitavano i privilegi ecclesiastici, suscitando le violente proteste del clero e degli aristocratici.
Alla nobiltà che guardava invece con simpatia la borghesia liberale, apparteneva il nuovo ministro dell’agricoltura, Camillo Benso di Cavour: aveva studiato con attenzione i problemi economici e si era convinto che lo sviluppo capitalistico esigeva decise misure di rinnovamento, dato che il pieno dispiegarsi del libero scambio, condizione essenziale del progresso, poteva realizzarsi solo nell’ambito di società prive dei vincoli assolutistici e dei residui feudali; Cavour vedeva l’indipendenza italiana come la naturale cornice di questo sviluppo, restando comunque del tutto ostile al pensiero radicale, e da questa sua posizione nettamente centrista si rivelò come l’esponente politico moderato più abile. Egli capì perfettamente che le posizioni democratiche non si potevano liquidare con la forza o tenere semplicemente ai margini del dibattito politico, quindi si pose subito il problema di dividere il fronte avversario, allacciando rapporti sempre più cordiali con la sinistra moderata, come appunto avvenne in occasione dell’ approvazione di vari trattati commerciali con i paesi più industrializzati, quando la sinistra parlamentare votò le proposte di Cavour. Ciò produsse addirittura una nuova maggioranza (che i conservatori definirono sprezzantemente “connubio”), il che era precisamente l’obiettivo di Cavour, nominato primo ministro alla fine del 1852 al posto di D’Azeglio, messo in minoranza dalla destra sull’introduzione del matrimonio civile.
Nelle file del movimento democratico europeo infuriava nel frattempo la polemica sulle ragioni di quanto era accaduto nel ‘48. Mazzini sosteneva che si era avuta la dimostrazione della maturità dei popoli rispetto alla questione nazionale e che la causa del prevalere della reazione fosse da ricercarsi nella frattura creata nel campo rivoluzionario dalle correnti socialiste: occorreva dunque bandire decisamente il concetto stesso di lotta di classe, fattore di divisione e d’impoverimento morale, e su questa base fondò a Londra (1850) il Comitato centrale democratico europeo; Mazzini era anche convinto che la spinta rivoluzionaria sarebbe nuovamente partita dall’Italia, dov'era crollato il mito del neoguelfismo, i moderati avevano dimostrato la loro incapacità di gestire la guerra d’indipendenza, e si erano avuti gli esempi straordinari di Roma, Milano e Venezia.
Da sinistra si obiettava che Mazzini si limitava ad enunciazioni di principio, senza guardare ai contenuti sociali del processo rivoluzionario, senza capire, cioè, che solo affrontando i bisogni concreti del popolo si potevano creare le condizioni per la vittoria sulla reazione: Carlo Pisacane fu il più lucido in questa critica, inserendola in una visione più ampia dell’evoluzione del mondo moderno e dando quindi al punto di vista socialista un carattere meno dottrinario e più aderente alla realtà; in sostanza Pisacane sosteneva che non c’era alcun contrasto fra lotta nazionale e lotta sociale, ma che anzi i due aspetti dovevano necessariamente fondersi affinché il mutamento politico fosse davvero tale. Questa corrente di pensiero, il cosiddetto socialismo risorgimentale, non riuscì tuttavia a fornire una concreta alternativa, soprattutto sul piano organizzativo, al programma mazziniano, che invece seppe creare importanti rapporti con le prime società operaie di mutuo soccorso: Mazzini sopravvalutò enormemente la robustezza delle proprie strutture rivoluzionarie e soprattutto non seppe cogliere i reali rapporti di forza venutisi a creare in Italia dopo il ‘48: convinto dell’esistenza di una situazione prerivoluzionaria, nel 1853 organizzò a Milano un tentativo insurrezionale, che però fu immediatamente stroncato dalla polizia austriaca.
All’inevitabile ulteriore ondata di critiche, Mazzini reagì con un inasprimento della propria intransigenza dottrinaria (verso sinistra rompendo del tutto coi socialisti, verso destra accentuando la pregiudiziale repubblicana), diede ai propri comitati una rigida struttura (Partito d’Azione) e continuò a sostenere che l’Italia fosse un paese pronto ad esplodere da un momento all’altro: ma i vari tentativi insurrezionali promossi dopo il ‘53 fallirono tutti, e andò quindi a rafforzarsi quella corrente democratica che riteneva politicamente indispensabile trovare qualche accordo con la monarchia sabauda: ne erano convinti gli stessi Garibaldi e Manin, che nel 1857 costituirono la Società Nazionale, con lo scopo di spingere Vittorio Emanuele e Cavour ad assumersi in prima persona la responsabilità di guidare la causa dell’indipendenza nazionale. Di fronte a questa iniziativa vi fu un riavvicinamento tattico tra Mazzini e Pisacane, che elaborarono un’azione insurrezionale coordinata fra Italia meridionale e settentrionale: nel giugno ‘57 Pisacane sbarcò con trecento uomini a Sapri (Salerno), ma l’atteso appoggio popolare non vi fu, anzi le autorità borboniche convinsero i contadini che si trattava di una banda di malfattori, e così i patrioti furono dispersi e uccisi; analogamente fallirono i tentativi di Genova e Livorno. Si è molto detto della spedizione di Sapri e dell’impossibilità della sua riuscita, ma ciò non toglie che Pisacane rimane comunque uno degli uomini che in quel periodo ha meglio analizzato il rapporto masse - rivoluzione, struttura sociale - indipendenza nazionale, e la sua fine è dovuta probabilmente alla volontà di lasciare un segno morale, una testimonianza simbolica.
Mentre la politica mazziniana era in evidenti difficoltà, il Piemonte andava rapidamente assumendo il ruolo che molti auspicavano, quello di motore e di guida dell’unità nazionale: ciò in buona misura fu dovuto alla solidità politica di questo Stato, basata sul mantenimento dell’ordine costituzionale, sul rafforzamento delle sue strutture economiche, sulla capacità di presenza nella scena internazionale.
A tutto ciò concorsero certamente figure di primo piano della cultura italiana, e in particolare il gruppo di esuli napoletani che faceva capo al letterato Francesco De Sanctis e al filosofo Betrando Spaventa, ma è senz’altro merito di Cavour l’aver impostato una politica di ampio respiro per uno Stato che rimaneva pur sempre una potenza di seconda grandezza: il grande contributo di Cavour sta appunto nell’essere riuscito a sprovincializzare il Piemonte, facendogli superare la tradizionale visione municipalistica e allargando la sua sfera d’interesse ben oltre il ristretto ambito regionale; del resto era esattamente questa la direzione verso cui guardava la nuova generazione di imprenditori, aperti all’innovazione, soprattutto nella siderurgia e nella meccanica legate allo sviluppo della rete ferroviaria, e decisi a inserirsi attivamente sui mercati internazionali. E fu proprio alla politica estera che Cavour dedicò una speciale attenzione: l’orientamento antiaustriaco era inevitabile, se il regno di Sardegna voleva diventare il polo di attrazione dell’unità, e Cavour seppe cogliere brillantemente l’occasione per sfruttare le tensioni fra le grandi potenze e inserire dinamicamente il Piemonte nel gioco diplomatico ad alto livello.
Nel 1853 lo zar Nicola I occupò alcuni territori balcanici sotto il dominio turco, e Francia e Inghilterra, preoccupate dall’espansionismo russo, si schierarono a fianco della Turchia, invitando le altre nazioni europee a fare altrettanto; la guerra si svolse in Crimea e mentre l’Austria esitava, temendo che il Piemonte potesse approfittarne per riaprire le ostilità sul territorio italiano, Cavour inviò (1855) un corpo di spedizione di 15.000 uomini comandati dal generale La Marmora e poté inserire il regno di Sardegna fra le potenze vincitrici: ciò gli consentì di porre con forza sulla scena europea lo squilibrio politico, rispetto allo stesso Congresso di Vienna, provocato dalla presenza di truppe austriache nello Stato pontificio: Inghilterra e Francia appoggiarono questa posizione e il fatto che l’Austria restasse politicamente isolata fu esattamente il risultato che si era prefisso Cavour, il quale per l’opinione pubblica italiana divenne il capofila della lotta per l’indipendenza.
Mentre allacciava rapporti sempre più stretti con la Società nazionale di Garibaldi e Manin, anche per isolare il movimento repubblicano, Cavour intesseva una complessa trattativa diplomatica con la Francia, immaginandola come il migliore alleato in vista di una futura guerra con l’Austria; il piano sembrò naufragare quando il repubblicano Felice Orsini compì un attentato, peraltro fallito, contro Napoleone III, nella speranza che la morte dell’imperatore avrebbe suscitato la ripresa repubblicana, ma Cavour seppe addirittura rovesciare a proprio vantaggio l’episodio, convincendo Napoleone ad affrettare i tempi dell’alleanza proprio per scongiurare l’eventualità di altre iniziative rivoluzionarie.
A scanso di equivoci Cavour adottò varie misure repressive contro i democratici e accusò pubblicamente i mazziniani di praticare la “teoria del pugnale”; Mazzini, che comunque era estraneo all’attentato, replicò con sdegno a questo evidente cinismo cavouriano, ma intanto il primo ministro piemontese aveva raggiunto lo scopo: nel luglio 1858 firmò con Napoleone l’accordo di Plombières, in base al quale venivano fissati gli obiettivi comuni da perseguire con la guerra all’Austria: creazione di un regno dell’Alta Italia, con l’annessione del Lombardo-Veneto al Piemonte, e di uno dell’Italia centrale; ridimensionamento dello Stato pontificio a Roma e ai territori circostanti; integrità territoriale del regno delle Due Sicilie; cessione alla Francia della Savoia e di Nizza.

La seconda guerra d’indipendenza scoppiò nell’aprile del 1859, e alle truppe regolari si affiancò un gruppo di volontari, i Cacciatori delle Alpi, guidati da Garibaldi: a Magenta e a Palestro i franco-piemontesi ottennero delle vittorie immediate e decisive, in parte bilanciate dallo scontro terribile di Solferino [fu proprio assistendo a questa atroce battaglia che Henry Dunant concepì l'idea di creare una struttura per l'assistenza dei feriti in guerra, la Croce Rossa] e Napoleone, temendo che la Prussia scendesse a fianco dell’Austria, propose un armistizio: questo fu firmato a Villafranca e prevedeva solo l’annessione al Piemonte di una parte della Lombardia e il ripristino dell’ordine nei territori (Toscana, Ducati, Stato pontificio) che si erano ribellati. Vittorio Emanuele II accettò di buon grado queste condizioni, ma Cavour rifiutò un compromesso che di fatto svuotava tutto il suo progetto e rassegnò le dimissioni.
La delusione per questa vergognosa soluzione diplomatica (che violava apertamente l’accordo di Plombières) non fu però sufficiente a liquidare l’entusiasmo dei patrioti italiani per quella che sembrava la svolta decisiva verso l’indipendenza, e, superando i dissidi interni, la Società nazionale e i mazziniani diedero il via all’insurrezione della Toscana: il granduca Leopoldo dovette fuggire e a Firenze si formò un governo provvisorio presieduto da Bettino Ricasoli; alcune settimane prima le truppe austriache di stanza nei ducati di Modena e di Parma e in Emilia Romagna erano state ritirate da quei territori per essere impegnate sul fronte, e quindi le manifestazioni e le rivolte non incontrarono ostacoli e portarono alla creazione di governi rivoluzionari; nelle Marche e nell’Umbria, invece, le truppe pontificie riuscirono a soffocare l’insurrezione. Questi avvenimenti erano esattamente ciò che l’armistizio di Villafranca voleva evitare, e, malgrado la grande prudenza del governo piemontese e l’evidente ostilità di Napoleone, i governi provvisori si prepararono alla resistenza, creando un esercito unificato al comando di Manfredo Fanti, che aveva come vice Garibaldi; la situazione sembrava doversi risolvere drammaticamente, quando (gennaio 1860) Cavour venne nuovamente chiamato a dirigere il governo: la sua iniziativa diplomatica puntò a un compromesso tra i rischi di restaurazione e l’allargamento della rivoluzione, e a fronte della cessione di Nizza e della Savoia ottenne il consenso di Napoleone all’annessione delle regioni dell’Italia centrale, che nel plebiscito del marzo 1860 votarono a larghissima maggioranza per questa soluzione.
Il processo di unità si era dunque bruscamente interrotto, ma ormai le forze democratiche non erano più disperse e minoritarie, e potevano anzi far valere a buon diritto il ruolo avuto nello scontro con l’Austria: il cammino verso l’unità non avrebbe tardato
Francesco II, da poco succeduto al padre sul trono, non sembrò dar segni di voler uscire dall’immobilismo tipico del regno di Napoli, malgrado il crescente malcontento delle masse contadine per le condizioni di miseria in cui si trovavano: era una situazione di crisi insanabile, ma le forze moderate che avevano gestito il movimento unitario si muovevano con grande cautela, visti i ristretti margini di manovra consentiti dal quadro diplomatico europeo; la prospettiva rivoluzionaria riprendeva dunque una propria concretezza e su di essa ritrovarono unità d’intenti sia i mazziniani del partito d’Azione che gli aderenti alla Società nazionale. Prese forma rapidamente il progetto di una spedizione militare, con Garibaldi come comandante, in Sicilia, dove maggiore era il contrasto fra governo borbonico e popolazione, e Cavour scelse una linea di attesa, consapevole di non poter appoggiare apertamente l’iniziativa ma di non poterla nemmeno impedire, visto il vasto consenso popolare acquisito dai democratici.

Qui un sito su Garibaldi
Agli inizi di maggio del 1860 da Quarto, vicino a Genova, un migliaio di volontari male armati, in parte provenienti dalle regioni del nord in parte esuli meridionali, partirono su due navi in direzione della Sicilia (Da Quarto al Volturno, di C. G. Abba, è l'interessante ricostruzione della spedizione): sbarcato a Marsala senza incontrare resistenza, Garibaldi emanò un decreto in cui assumeva la dittatura dell’isola “in nome di Vittorio Emanuele II re d’Italia”, e in poche settimane travolse l’esercito borbonico, battendolo a Calatafimi, entrando trionfalmente a Palermo e ottenendo la vittoria decisiva a Milazzo. Il governo provvisorio presieduto da Francesco Crispi, futuro primo ministro italiano, fu in realtà assai prudente, e si guardò bene dal prendere provvedimenti analoghi a quelli adottati a suo tempo dalla repubblica romana, anzi, di fronte ai movimenti che reclamavano la riforma agraria, non esitò ad agire con estrema durezza: nel paese di Bronte, dove i contadini avevano occupato le terre dei latifondisti, Nino Bixio, vicecomandante dei garibaldini, comandò di persona la violenta repressione. Un episodio emblematico della contraddizione di fondo del processo unitario: si andava formando un’entità nazionale basata più sui principi politici che sulla loro concreta attuazione, e gli interessi della borghesia agraria e industriale prevalevano nettamente sulle esigenze di riforma sociale e di riequilibrio delle condizioni economiche.
Sbarcate in Calabria, le truppe di Garibaldi furono accolte con entusiasmo dalle popolazioni e riuscirono rapidamente ad avere la meglio su un esercito borbonico demotivato e privo di una guida adeguata: con l’occupazione di Napoli e con la battaglia sul Volturno, nell’ottobre, il regno delle Due Sicilie non esisteva più.
Le forze democratiche vedevano dunque confermate le loro previsioni e si andava nettamente rafforzando, anche nei settori moderati dell’opinione pubblica, l’idea che l’unità italiana dovesse comprendere senz’altro tutte le regioni della penisola, compresa Roma, e che l’obiettivo era ormai a portata di mano; l’iniziativa politica era ormai tutta a vantaggio dei democratici, e Cavour dovette intervenire con decisione per non essere tagliato fuori: convinse Napoleone che occorreva evitare uno sbocco rivoluzionario generalizzato e che per far ciò era indispensabile attivare immediatamente un contrappeso politico-militare; le truppe piemontesi del generale Fanti occuparono le Marche e l’Umbria, battendo l’esercito pontificio, e lo stesso Vittorio Emanuele prese poi il comando delle operazioni, dirigendosi verso il confine napoletano e incontrando Garibaldi a Teano. Ancora una volta Cavour aveva visto giusto e il tempestivo intervento dell’esercito regolare aveva di fatto tolto ai democratici la possibilità di proseguire la rivoluzione democratica o comunque di influenzare in senso antimoderato il processo unitario: con una procedura già collaudata, fu attuata l’annessione di Marche, Umbria e Due Sicilie al Piemonte, l’esercito garibaldino venne sollecitamente smantellato, il controllo politico e amministrativo sui nuovi territori fu assunto direttamente dai funzionari piemontesi e Garibaldi se ne tornò nella sua Caprera.
Liquidata l’ultima resistenza borbonica a Gaeta, nel febbraio 1861, il processo unitario si era dunque concluso sotto l’egemonia moderata e il nuovo Stato nasceva all’insegna della salda alleanza fra borghesia liberale del nord e agrari conservatori del sud. A metà febbraio si riunì a Torino il primo parlamento nazionale, che ratificò l’unificazione e il 17 marzo 1861, due mesi prima della morte di Cavour, fu proclamato il regno d’Italia.
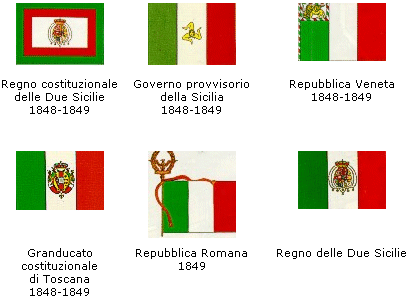
DAL LIBERALISMO ALLA COMUNE
La borghesia europea aveva definitivamente abbandonato qualsiasi velleità rivoluzionaria, scegliendo al tempo stesso il principio della sovranità nazionale come base dell’evoluzione politica e dello sviluppo economico: era l’espansione stessa del capitalismo che richiedeva la rottura coi vecchi equilibri feudali, ma questa svolta liberale avvenne in modo diverso nei vari paesi.
Se in Italia nazionalismo e libertà avevano in qualche modo trovato una loro armonia, in Germania l’unificazione si realizzò, al contrario, con la sconfitta dei liberali. A guidare il percorso unitario fu la Prussia, cioè il paese che era diventato il primo produttore europeo di carbone (nelle regioni della Ruhr e della Slesia) e di acciaio, e che per la sua forza industriale aveva saldamente in mano l’economia della regione tedesca, anche tramite l’unione doganale (Zollverein) da essa stessa impostata; alle ragioni ideali dell’unificazione, di cui già si erano fatti portatori gli intellettuali, si vennero quindi ad aggiungere i motivi assai più concreti della borghesia imprenditoriale: diversi, però, erano i modi per raggiungere l’obiettivo, perché i liberali ritenevano indispensabile disegnare un quadro costituzionale e parlamentare, mentre l’aristocrazia prussiana - anch’essa, con gli Junker, impegnata direttamente nelle attività agricole e industriali - non intendeva perdere la propria posizione preminente e vedeva il processo come affermazione del primato della monarchia di Prussia. Il nuovo re Guglielmo I nel 1852 affidò l’incarico di cancelliere a Ottone di Bismarck, aristocratico e conservatore, deciso fautore dell’unificazione, che pensò subito a un forte rafforzamento militare inteso come base dell’egemonia sugli altri Stati tedeschi e della competizione con l’Austria; imbastì poi un’accorta politica delle alleanze, da una parte assicurandosi la neutralità della Francia, dall’altra accordandosi con l’Italia per attaccare l’Austria su due fronti, con l’impegno che in caso di vittoria il Veneto sarebbe diventato italiano: la guerra (che per l’Italia passò alla storia come terza guerra di indipendenza) fu dichiarata nel 1866, e iniziò con due sconfitte italiane, a Custoza e nella battaglia navale di Lissa, compensate però nettamente dalla vittoria del fortissimo esercito prussiano a Sadowa: il trattato di pace stabilì, oltre al passaggio del Veneto all’Italia e allo spostamento della capitale da Torino a Firenze, che gli Stati tedeschi del nord si sarebbero riuniti in una Confederazione Germanica presieduta da Guglielmo I, governata dal cancelliere Bismarck, e, importante novità, con un parlamento federale (Reichstag) eletto a suffragio universale; gli Stati tedeschi del sud si riunirono in una Confederazione autonoma, ma era evidente la loro subordinazione a Bismarck, che uscì come il trionfatore di questa politica che mescolava abilmente assolutismo e liberalismo, supremazia prussiana e visione nazionale.
Pesanti furono le conseguenze per l’impero austriaco, che non poté più rinviare una revisione del proprio assetto: mentre alle varie nazionalità vennero riconosciuti alcuni elementi di autonomia, all’Ungheria fu riconosciuto il particolare status di monarchia autonoma, con un proprio parlamento e una propria capitale, fermo restando che la potenza austro-ungarica era tenuta unita dal ruolo centrale dell’imperatore. Inevitabile che le nazionalità minori fossero del tutto insoddisfatte: i cechi continuavano a sperare di ricostituire il regno di Boemia, gli sloveni volevano riunirsi in un unico Stato con serbi e croati, ma Francesco Giuseppe fu molto cauto nelle concessioni e il problema non fu risolto, solo rinviato. In Russia il pugno di ferro contro i decabristi aveva ottenuto il risultato desiderato (o meglio, dilazionò di qualche decennio la ripresa attiva di un movimento di opposizione), e il regime si era consolidato ulteriormente in seguito alla repressione della rivoluzione nazionalista polacca (1830-1) e, soprattutto, grazie al fatto di essere riuscito ad evitare il contagio rivoluzionario del ‘48. Ma la situazione economica e sociale dell’impero era sempre più pesante: le rivolte contadine avevano ripreso a diffondersi, il mercato interno tendeva a restringersi sempre più, la bilancia commerciale estera era in grave passivo, e si ampliavano i settori dell’imprenditoria (e anche della media aristocrazia terriera) che reclamavano una svolta. Dopo la sconfitta del ‘57 in Crimea, anche per la Russia si pose il problema di una qualche riforma e il nuovo zar Alessandro II avviò cauti mutamenti, allentando la censura e la repressione, amnistiando molti detenuti politici; rimasero invece in esilio Alexandr Herzen e Michail Bakunin, rispettivamente il principale precursore del marxismo russo e il grande teorico anarchico, la cui influenza contribuì moltissimo a far crescere una nuova generazione di rivoluzionari, numericamente più estesa e politicamente più preparata dei pur eroici decabristi. Sul piano economico l’arretratezza russa era paurosa, e al tradizionale immobilismo delle classi dirigenti andò lentamente sostituendosi un’apertura agli investitori stranieri; rimaneva però irrisolto quello che era il problema fondamentale, cioè il permanere delle vecchie strutture feudali, alla cui base stavano la grande proprietà terriera e la servitù.
Qualcosa di nuovo accadde quando nel 1861 lo zar fece pubblicare il manifesto che annunciava la liberazione dei servi: i contadini erano formalmente resi liberi nelle loro persone e ottenevano il diritto di acquistare le terre che coltivavano, ma queste erano ridotte alle particelle più scadenti, ed essendo enormemente sopravvalutate i contadini s’indebitavano verso lo Stato per somme esorbitanti, spesso superiori allo stesso reddito che avrebbero potuto ricavare dagli appezzamenti; d’altro canto i proprietari mantenevano le proprie rendite parassitarie e una cospicua serie di diritti feudali, in taluni casi acquisendone addirittura di nuovi, come quello di esercitare il diritto di proprietà sulle terre originariamente della comunità di villaggio (il mir). Insomma, non era certo una vera riforma agraria borghese, né tanto meno la soluzione della questione contadina, e il mercato interno non ne ricavava alcun beneficio; e tuttavia, viste le condizioni del paese, la riforma del 1861 (che istituiva anche alcune limitate forme di amministrazione locale elettiva, con ciò permettendo ai gruppi più omogenei della borghesia di organizzarsi e di far sentire in qualche modo la propria voce) fu comunque un balzo in avanti verso la formazione di un moderno paese capitalistico. Significativamente, però, proprio nei giorni di pubblicazione del manifesto, lo zar “buono” diede personalmente l’ordine di sciogliere a fucilate una dimostrazione di protesta a Varsavia, provocando amarezza e disillusione in tutti coloro che avevano dato credito alla volontà riformatrice dello zar; e infatti riprese forza il movimento rivoluzionario, orientandosi in due grandi filoni, il populismo e il nichilismo: i populisti, richiamandosi in parte al pensiero di Herzen e in parte alle teorie del grande scrittore Nikolaj Cernycevskij, ritenevano che compito dell’intelligencija fosse di mettersi “al servizio del popolo”, dando soprattutto ai contadini la cultura necessaria per costruire il movimento rivoluzionario: una concezione aristocratica e astratta, ben diversa dal rapporto intellettuali - masse poi messo a fuoco dal marxismo, ma che pure svolse un importante ruolo nell’avvicinare i borghesi illuminati ai problemi delle classi oppresse.
Bakunin, che aveva partecipato alla rivoluzione tedesca del ‘48 e che svolse la sua attività soprattutto in occidente (dove orientò una corrente importante del primo socialismo, l’anarchismo), rovesciò la concezione populista: non è la persona colta che deve insegnare al popolo, ma viceversa, poiché i meccanismi dello sfruttamento sono fin troppo chiari a chi li sperimenta quotidianamente, rivelandosi invece inaccessibili agli intellettuali; questi, casomai, possono usare le loro conoscenze per dare una forma organica alla ribellione spontanea, ma caotica, delle masse; per Bakunin lo scontro con il potere non poteva avere alcuna mediazione politica ed aveva un solo scopo, la distruzione dello Stato; alle sue posizioni estreme, che avevano al centro l‘idea mitica di un popolo “istintivamente rivoluzionario” si possono ricondurre i gruppi nichilisti, che ebbero una rapida quanto breve affermazione nel movimento rivoluzionario, ma lasciarono tracce significative, ad esempio nell’uso dell’azione individuale o terroristica.
In quegli anni in Inghilterra continuava, sempre sotto l’impulso del lavoro teorico di Mill, l’azione liberale per la riforma elettorale: il nuovo premier, il conservatore Benjamin Disraeli, fu costretto a far approvare nel 1867 una riforma che raddoppiò il numero degli elettori, ma con grande abilità seguì una tattica di rifiuto delle richieste politiche popolari e di apertura verso le rivendicazioni sindacali. Un altro grande protagonista della politica britannica fu il liberale William Gladstone, che dopo la vittoria del proprio partito guidò il governo: egli cercò di affrontare la questione irlandese, cioè la drammatica condizione di un paese ancora quasi al rango di colonia, con un’enorme massa di contadini poveri e la proprietà terriera in mano a pochi latifondisti: la resistenza accanita degli agrari bloccò ogni riforma, e molti irlandesi furono costretti all’emigrazione, mentre nel paese si andava organizzando quel movimento autonomista che vedeva nel dominio inglese la causa prima della miseria e che sarebbe esploso qualche decennio più tardi.
 Negli Stati Uniti il contrasto fra Nord industrializzato
e Sud agricolo andava rapidamente verso una frattura insanabile; la
questione della schiavitù era solo l’elemento simbolico
di un conflitto che in realtà verteva su come impostare la strategia
economica governativa e organizzare lo sviluppo politico dell’Unione:
al nord si puntava a una legislazione protezionista fra Stato e Stato
ed al rafforzamento del potere federale, mentre il sud era per il completo
liberismo economico e la più ampia autonomia dei singoli Stati,
e lo scontro si polarizzò sul concedere o meno ai nuovi Stati
la facoltà di praticare la schiavitù; con la sconfitta
del partito democratico (che aveva peraltro una forte minoranza abolizionista)
e l’elezione a presidente del repubblicano Abraham Lincoln (1861), gli Stati del sud giudicarono che non sarebbero più riusciti
a estendere la schiavitù (cioè il modello economico della
grande azienda agraria) all’ovest, e undici fra loro attuarono
la secessione, formando la Confederazione. La guerra
civile fu immediata, e il nord, che peraltro era avvantaggiato sia dalla
superiorità numerica sia da un apparato industriale assai più
robusto, soprattutto dopo aver abolito la schiavitù (1862) poté anche agitare la bandiera umanitaria e godere dell’appoggio
dell’opinione pubblica internazionale, che infatti impedì
all’ Inghilterra di aiutare i confederati; il comandante delle
truppe sudiste, il generale Robert Lee, per due anni
riuscì con straordinaria abilità a fronteggiare e addirittura
a battere l’esercito nemico, ma la sproporzione delle forze e
il blocco navale nordista sulle coste meridionali (con conseguente mancanza
di rifornimenti e l’impossibilità di scambi commerciali
che portassero denaro fresco nelle casse confederate) alla lunga furono
decisivi: con la vittoria di Gettysburg l’Unione
invertì il corso della guerra e l’abilità strategica
del generale Ulysses Grant tagliò in due, attraverso
il Mississippi, il territorio confederato; la battaglia finale di Richmond (aprile 1865) chiuse una delle guerre più sanguinose mai viste,
e la vittoria nordista diede il via a un’ulteriore accelerazione
sia dello sviluppo industriale sia della conquista del West.
Negli Stati Uniti il contrasto fra Nord industrializzato
e Sud agricolo andava rapidamente verso una frattura insanabile; la
questione della schiavitù era solo l’elemento simbolico
di un conflitto che in realtà verteva su come impostare la strategia
economica governativa e organizzare lo sviluppo politico dell’Unione:
al nord si puntava a una legislazione protezionista fra Stato e Stato
ed al rafforzamento del potere federale, mentre il sud era per il completo
liberismo economico e la più ampia autonomia dei singoli Stati,
e lo scontro si polarizzò sul concedere o meno ai nuovi Stati
la facoltà di praticare la schiavitù; con la sconfitta
del partito democratico (che aveva peraltro una forte minoranza abolizionista)
e l’elezione a presidente del repubblicano Abraham Lincoln (1861), gli Stati del sud giudicarono che non sarebbero più riusciti
a estendere la schiavitù (cioè il modello economico della
grande azienda agraria) all’ovest, e undici fra loro attuarono
la secessione, formando la Confederazione. La guerra
civile fu immediata, e il nord, che peraltro era avvantaggiato sia dalla
superiorità numerica sia da un apparato industriale assai più
robusto, soprattutto dopo aver abolito la schiavitù (1862) poté anche agitare la bandiera umanitaria e godere dell’appoggio
dell’opinione pubblica internazionale, che infatti impedì
all’ Inghilterra di aiutare i confederati; il comandante delle
truppe sudiste, il generale Robert Lee, per due anni
riuscì con straordinaria abilità a fronteggiare e addirittura
a battere l’esercito nemico, ma la sproporzione delle forze e
il blocco navale nordista sulle coste meridionali (con conseguente mancanza
di rifornimenti e l’impossibilità di scambi commerciali
che portassero denaro fresco nelle casse confederate) alla lunga furono
decisivi: con la vittoria di Gettysburg l’Unione
invertì il corso della guerra e l’abilità strategica
del generale Ulysses Grant tagliò in due, attraverso
il Mississippi, il territorio confederato; la battaglia finale di Richmond (aprile 1865) chiuse una delle guerre più sanguinose mai viste,
e la vittoria nordista diede il via a un’ulteriore accelerazione
sia dello sviluppo industriale sia della conquista del West.
Dato che gli Stati Uniti erano impegnati in queste drammatiche vicende interne, Napoleone III approfittò della loro impossibilità a far rispettare la dottrina Monroe e cercò in America latina l’occasione per concretizzare le proprie ambizioni imperiali: d’accordo con l’Austria nel 1864 inviò un corpo di spedizione in Messico, retto dal governo progressista di Benito Juarez, con l’idea di affidare la gestione del potere a Massimiliano d’Asburgo; la fiera resistenza opposta dai messicani, la fine della guerra civile al nord e la crisi europea del 1866 indussero però Napoleone a ritirare le truppe e ad abbandonare l’Asburgo al suo destino: sconfitto dai soldati di Juarez, Massimiliano fu catturato e fucilato l’anno dopo.
In patria Napoleone III svolgeva la sua ambigua ma fortunata politica fatta di potere personale e di concessioni liberali, mentre sul piano internazionale continuava a tutti i costi nel tentativo di riportare la Francia alla gloria di un tempo, e in quest’ottica non c’era altra possibilità che quella dello scontro con la Prussia, in quel momento il paese europeo più in vista. Specularmente Bismarck vedeva in questo confronto un’ottima occasione per rafforzare la Confederazione e completare l’unificazione tedesca, e con meticolosità tutta prussiana si preparò alla guerra. Il pretesto fu, abbastanza anacronisticamente, una controversia dinastica relativa al trono di Madrid, sul quale il cancelliere tedesco propose fosse insediato un principe Hohenzollern: la provocazione era evidente, la stampa nazionalista francese tuonò contro il pericolo dell’accerchiamento tedesco a nord e a sud, e Napoleone, che a differenza di Bismarck non aveva predisposto un’efficiente macchina bellica, venne spinto al disastro: la guerra franco-tedesca non durò lo spazio d’una estate e il 2 settembre 1870 a Sedan un esercito di centomila francesi fu annientato.
Il popolo insorse contro l’imperatore e lo rovesciò, e il neocostituito governo della Terza repubblica decise la resistenza ad oltranza: per quattro mesi Parigi sostenne l’assedio tedesco, mentre i volontari di Garibaldi tenevano impegnati i prussiani a sud, finché la resa fu inevitabile, costringendo la Francia a cedere le regioni di confine dell’Alsazia e della Lorena, che diventarono poi motivo di profondo rancore antitedesco. E proprio durante l’assedio Bismarck completò il proprio trionfo: riuniti in solenne assemblea i principi tedeschi proclamarono il re di Prussia Guglielmo I imperatore di Germania.
Mentre nei sobborghi della capitale stazionavano ancora le guarnigioni prussiane, lo sdegno dei parigini per la disastrosa avventura bellica e la rabbia per le conseguenze terribili dell’assedio (soprattutto fame e disoccupazione) si trasformò in aperta rivolta: il 18 marzo 1871 un Comitato centrale rivoluzionario prese il potere e convocò un’Assemblea costituente, mentre il governo insediatosi a Versailles e presieduto dal moderato Thiers ritirò le truppe per evitare che fraternizzassero con gli insorti.
Alle elezioni generali dell’Assemblea municipale (Comune di Parigi) i socialisti conquistarono la maggioranza e formularono un programma molto avanzato sul piano della democrazia politica e sociale, basato sul decentramento dei poteri e sulle riforme economiche. I tedeschi liberarono di buon grado molti prigionieri che andarono a rinforzare le file dell’esercito di Thiers e le truppe governative iniziarono un secondo, terribile assedio.
La resistenza, a cui si può dire che partecipò tutta la città, fu eroica e durò due mesi, e quando i soldati di Thiers entrarono in città dovettero ancora combattere per sette giorni al fine di snidare tutti i rivoltosi: durante questa “settimana di sangue” agli oltre 20.000 parigini già caduti si aggiunsero le migliaia di esecuzioni sommarie, e poi ancora circa 50.000 processi e condanne.
